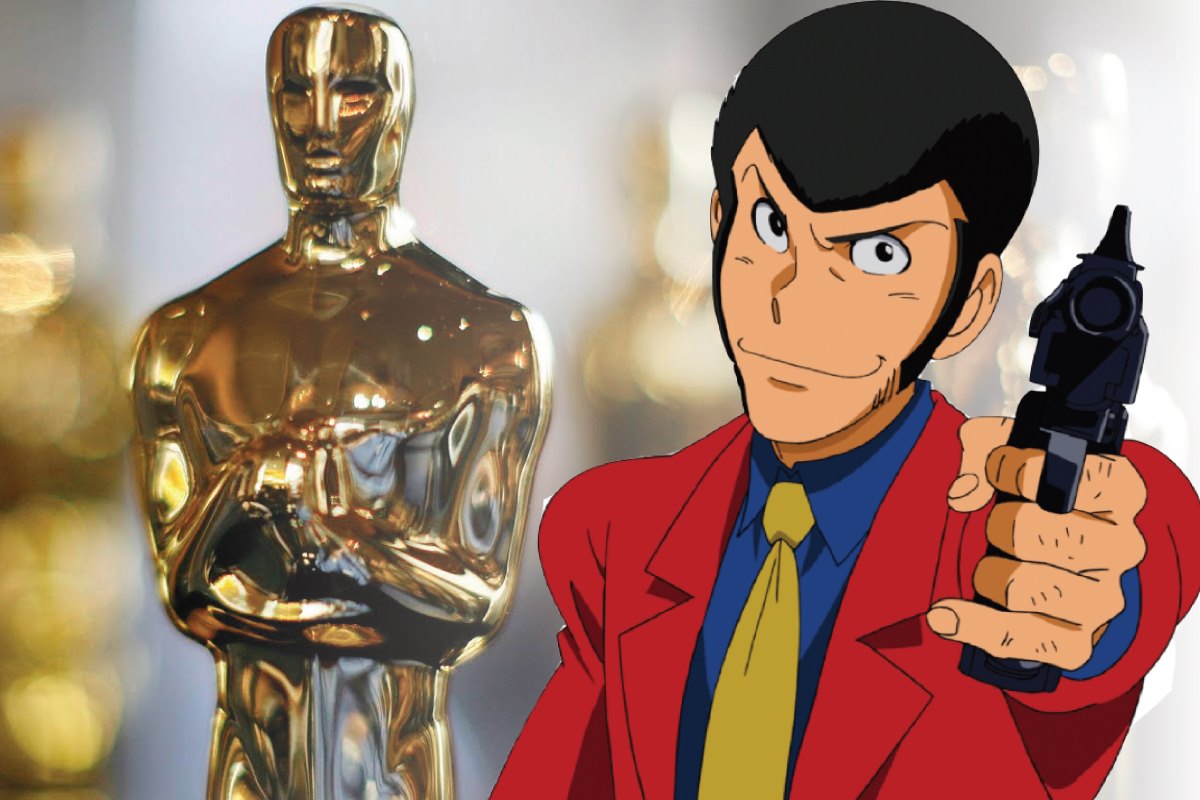Un racconto descritto in maniera realistica con toni grotteschi. Si assiste alla crescita di quel menhir di vetro simbolo delle schiavitù alla rassegnazione.
“Ci fermavamo lì davanti, ci sedevamo sul primo spazio del marciapiede libero: chi con una sigaretta chi con uno spinello e chi con la sua birra. Era un cinema gratuito, cioè, era come se fosse un cinema gratuito. La cosa più importante era fare attenzione durante lo spettacolo a non avere nulla in bocca: ho visto più di un ragazzo arrivare vicino al soffocamento”.
L’autista scese dal camion e soffermò a lungo lo sguardo verso il suo carico. Non mancava molto, era quasi arrivato ma doveva aspettare che la pattuglia della polizia stradale che gli faceva da scorta si avvicendasse con i colleghi del comune dove avevano appena fatto ingresso. Diversi curiosi si avvicinarono. Visto dal vetro dell’autogrill il carico doveva sembrare a dir poco surreale: alto almeno quindici metri, per dieci di larghezza e due di spessore, disposto in verticale, 16 piloni di acciaio, otto da un lato e otto dall’altro, a puntellare la gabbia di ferro dentro la quale era avvolto in un cartone giallo e in uno strato di pluriball.
“Quando lo installarono, tutti noi sapevamo cosa fosse. Non sapevamo perché fosse lì. Nessuno ce lo spiegò ma ben presto fu chiaro, almeno credo. Non può essere una dimenticanza, non so perché le cose oggi vanno così, credo però che questo in realtà sia il vero significato dell’opera”.
La seconda pattuglia dopo poco arrivò, gli agenti si scambiarono qualche sorriso e poi fecero cenno all’autista di rimontare nell’abitacolo. Arrivare fin là non era stato per lui difficile, l’ingombrante carico era stato ritirato presso il porto. Per caricarlo avevano dovuto utilizzare la gru Liebherr LR 11350, una delle poche in circolazione in grado di sollevare pesi che superavano le cinquecento tonnellate.
“Li vedevi arrivare, sereni, tranquilli, alcuni anche serafici, certo qualcuno anche arrabbiato o pensieroso, qualcuno dalla faccia innamorata, in molti al telefono. Quando arrivavano quelli in scarpe da ginnastica, con i calzettoni fin sotto il ginocchio, con degli improbabili pantaloncini old-style, magari anche in canotta, allora ti dovevi reggere perché ridevi talmente tanto che le gambe ti cedevano. Ma in assoluto i più divertenti e forse anche drammatici erano quelli in bicicletta.”
L’autista aveva dovuto studiare attentamente il percorso prestabilito, il millepiedi rosso dalle ruote nere attaccato all’autotreno necessitava della massima attenzione e un solo errore avrebbe potuto comportare gravi ritardi e gravi disagi. Ma a preoccuparlo non era il lavoro bensì i pensieri che quella mattina occupavano la sua mente.
“Penso che fosse contro la guerra, la guerra in generale, quella che porta distruzione e morte, quella che ti fa dimenticare di essere un uomo, quella che ti fa commettere azioni indicibili. Si, penso che fosse per ricordare, ed oggi lo abbiamo dimenticato, che nonostante si sappia e si abbia piena consapevolezza dell’inutilità e delle atrocità della guerra, queste vengono comunque perpetrate nonostante ogni ferma, singolare ed ovvia obiezione”.
Perché mai la moglie lo avesse portato ben oltre la mezzanotte per convincerlo sull’importanza vitale che aveva una conversione dell’umanità al veganesimo non lo capiva. Non capiva nemmeno come avesse fatto suo figlio ad innamorarsi perdutamente della commessa di Foot-looker e non accettava che sua figlia Adele avesse iniziato di nascosto a fumare. Alla somma delle cose che non gli quadravano si aggiungeva poi il non capire neppure perché mai si ritrovasse un monolite, sul rimorchio dell’autotreno, così grande da non permettergli neppure di fermarsi a pisciare senza essersi coordinato con la pattuglia della stradale che lo seguiva, che a sua volta avrebbe dovuto coordinarsi con l’automezzo dei vigili del fuoco e con le due auto della protezione civile che li precedevano.
“Presumo che fosse contro la mafia. Forse rappresentava l’omertà delle persone, quella forma di silenzio che è la cosa che più si avvicina alla complicità. Quell’omertà che nega la giustizia anche se è lì e la potresti afferrare. Si, il non poter afferrare la giustizia ma vederla”.
Poteva pure passare che le salsicce e i wurstel fossero mortali, ma da questo decidere di non mangiare più ne carne ne pesce, ne derivati di questi, gli sembrava una follia. “Se fossi te una mucca? Saresti contento di essere nato solo per farti macellare? Se fossi un vitello ne vogliamo parlare? E di quei poveri maiali, o dei polli? Degli allevamenti in batteria? Delle pellicce?” Domande del genere… e ad ogni sua risposta c’era un’altra domanda di sua moglie. E la cosa che gli faceva più rabbia era di non essersi ricordato dell’esperimento del fagiolo per controbattere a tutte le accuse d’insensibilità e di cinismo da lei mossegli.
“Una volta, mi ricordo bene, arrivò un tizio in bicicletta. Sai di questi che si vestono come se dovessero fare il giro d’Italia? Accanto a me era seduto un ragazzo che per poco non si sentì male. L’avevamo notato da lontano, e già avevamo iniziato a ridere, il tizio accanto a me più di tutti. Pedalava con convinzione e sentimento. Non ci eravamo resi conto della velocità almeno finché non fu troppo vicino. Troppo perché, anche se ci fossimo sbracciati, a quella velocità per lui non si poteva fare più nulla. Cacchio se lo sapeva! Tutti lo sapevano! Il mondo intero lo sapeva! Eppure a decine tutti i giorni se lo dimenticavano. Vi garantisco che la dimenticanza è dolorosa. Ma forse come vi dicevo prima era proprio questo la ragione, il vero significato, non dimenticare. Tornando al ciclista, la prima cosa che impattò fu il manubrio, poi lo raggiunse la faccia seguito da un groviglio di gambe e catena, braccia e sellino, culo e ruote. Oltre al rumore sordo dell’impatto c’erano le nostre risate. Il tizio accanto a me lo vidi letteralmente diventare blu, rideva talmente tanto da non riuscire più a prendere fiato. So che non è una bella cosa sbellicarsi quando un tuo simile si fa male soprattutto se si tiene conto che lo dovettero mettere nell’eliambulanza con tutta la bici, ma ricordare quel rapido mutare delle espressioni facciali, vederle passare da spensierate a sorprese per poi divenire impaurite e virare infine a terrorizzate, oggi mi fa ancora ridere. Rido ancora perché è questo lo scopo, ne sono certo”.
Se posizioni un asticella accanto ad un germoglio di fagiolo, questo riesce a raggiungerla: non lo fa per tentativi, spostandosi a 360° in tutte le direzioni, ma cresce sempre nella direzione del sostegno finché non l’ha raggiunto. Bada bene, che non si fa fregare neanche dal primo sadico bastardo che gli sposta l’asticella, perché se ciò dovesse accadere lui lo percepisce e immediatamente cambia direzione verso il nuovo posizionamento. Ecco, questo è quello che doveva dire e non aveva detto. E tutte quelle domande sarebbero potute essere rigirate: “Se fossi te fagiolo? Saresti contento di essere nato solo per farti coltivare? Se fossi un germoglio di soia ne vogliamo parlare? E di quei poveri ceci, o del farro? Degli allevamenti in serra? Dei vestiti in canapa?” Comunque la questione, anche se capovolta, ritornava alle cause che l’avevano originata: per rispondere alle crescenti richieste di generi alimentari l’unico sistema era quello di intensificare la produzione di quel genere e ciò non poteva avvenire se non accettando compromessi con l’etica in genere e con la propria coscienza in particolare. Essere disposti a non vedere o perlomeno essere disposti a vedere e far finta di non sapere: la consapevolezza e la sua inutilità al contrario non sarebbe potuta arrivare se non in modo doloroso.
“Cioè lo scopo non è ridere”.
Il navigatore, preimpostato, dichiarava dieci minuti all’arrivo. Quel tratto di strada a quella velocità ne richiedeva almeno sessanta. Intorno a lui, semafori lampeggianti, vigili urbani, curiosi. Il caos cittadino sembrava paralizzato al suo passaggio. Come se la città si stesse preparando a fare un inchino. Dietro al volante, si sentiva sicuro; dall’alto poteva osservare la città aprirsi al suo passaggio. Eppure il turbinio dei pensieri lo riportò in famiglia. Dieci? Venti? Quante sigarette si fumerà al giorno? Perché vendono un prodotto con sopra scritto che uccide te e chi ti sta vicino? Perché compri una condanna ad un lento suicidio? Ma anche in questo caso la risposta sembrava essere:” meglio non averne consapevolezza”. Già, la consapevolezza, un termine che si accostava perfettamente anche a suo figlio. Quei sorrisi della commessa erano per tutti, non solo per lui, ma lui li riteneva speciali, unici. Per l’ennesima volta rischiava di passare per uno stalker: non a caso era giorni che non vedeva più quella ragazza che probabilmente si nascondeva al suo arrivo. Non si trattava di pregiudizi paterni ma di giudizi fondati, perché prima della commessa del negozio c’erano state due bariste, l’insegnante di spinning, la ragazza delle ripetizioni, l’infermiera del centro donazione sangue e la parrucchiera. Quello che gli era bastato era un sorriso e con quel sorriso costruiva un mondo e poi si disperava nel vederlo crollare. Era come andare a sbattere contro un muro di vetro pur sapendo della sua esistenza: vuoi vedere oltre, dove oltre in realtà non puoi andare ma eventualmente puoi solo vedere.
“Quando giunse il Tir con l’immenso carico, io e molti altri eravamo lì. Erano le 8 di mattina. In molti ci domandavamo cosa ci fosse sotto quel rivestimento e come avessero fatto a portarlo lì e perché mai non lo avessero smontato per poi ricomporlo. Tutta l’area intorno all’autocarro fu transennata e dei teli alti come un palazzo furono disposti in modo tale da non permetterci di vedere nulla. Rimanemmo lì fino a tarda sera, poi, saranno state le 5 del mattino, come delle formiche impazzite, tutti i mezzi se ne andarono e l’ultimo, attraverso un argano montato sul paraurti anteriore, tirò via i teli bianchi dall’opera e a gran velocità si dileguò”.
Poco dopo essere giunto al punto di arrivo, lui, il suo tir e il suo carico furono circondati da grandi teli bianchi. Scese dall’autotreno e gettò lo sguardo nuovamente verso il suo carico. Avrebbe voluto saper cosa fosse ma non glielo permisero. L’unica cosa che gli restava da fare era tornarsene a casa e provare ad affrontare l’inaffrontabile.
“Un muro di vetro, immenso, spesso almeno come un uomo sdraiato. Rimasi lì ad osservarlo per ore e poi mi avvicinai e lo toccai. Nella parte in basso, sulla grande pedana piatta e sottile c’era una targa in bronzo con sopra inciso – non sempre ciò che vedi è raggiungibile ma se vuoi puoi provare -. E da quel giorno io e gli altri passammo quasi tutti i pomeriggi lì con la speranza di vedere qualcuno riuscire. Ridendo degl’ovvi e dolorosi fallimenti.
Il menhir di vetro ebbe risonanza mondiale, addirittura dall’estero venivano per vederlo. Spesso stavamo lì seduti e accanto a noi si sedevano cinesi, francesi, americani, russi, alcuni venivano addirittura dal Lesotho, che ancora oggi non ho capito se si tratta di una città, di una nazione o di un pianeta. Tutti lì a fissare il grande blocco di vetro. La rappresentazione di ciò che è possibile vedere o forse capire ma che è impossibile da realizzare. Non so se per tutti ha lo stesso significato, forse per il ciclista è diverso, ma quello che penso è che in fin dei conti non è che un inno alla consapevolezza della rassegnazione che si rinnova attraverso il dolore di chi se ne dimentica e le risate di chi sta lì a guardare”.