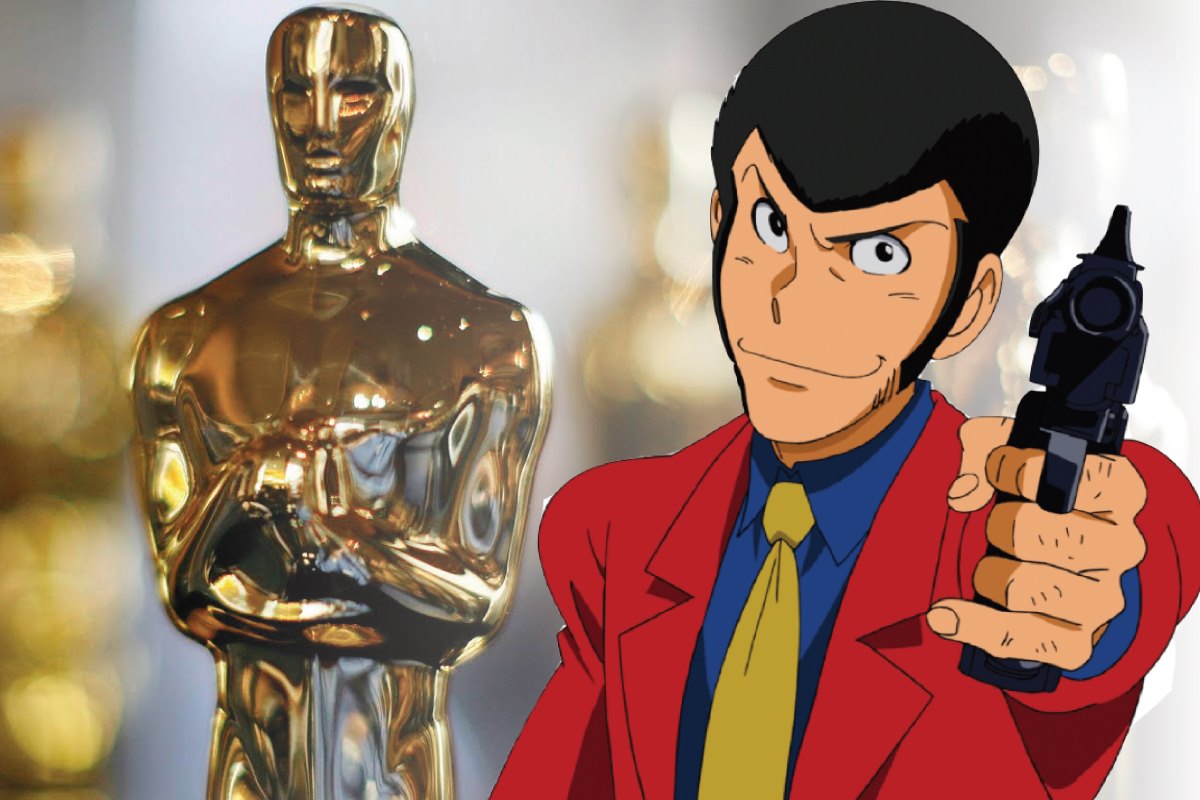Il mio nome era Norma Jean ma mi chiamavano Marilyn.
1 marzo 1961
Quattro pareti spoglie, sbarre ovunque e, nascosta nella mano, una scheggia ottenuta sbattendo una sedia contro il vetro del bagno, con la stessa isteria e drammaticità che si addicono a un’attrice navigata.
Non è un albergo di New York e davanti a Marilyn si stagliano minacciosi quattro infermieri della clinica Payne Whitney, l’ospedale psichiatrico in cui si trova momentaneamente in cura, oggetto di molti dei suoi incubi e delle fantasie più deprimenti: come sua madre, come sua nonna.
Si pensa questo di lei mentre minaccia di farsi del male davanti al personale che la tiene ‘prigioniera’ e non le permette di fare neanche una telefonata? Non ha in mano un rasoio come in La tua bocca brucia e non è una baby sitter. Sono passati quasi dieci anni da quel ruolo che rese palpabile, a chi voleva accorgersene, il seme del male di quel suo talento negato da Darryl Zanuck.
Home Town Story e Giungla d’asfalto, altre due prove di forza, sembrano far parte della vita di un’altra persona.
Gli spostati, l’opera che coglie più di tutte l’anima frantumata di Marilyn, è uscito da poco e la sua eroina scrive al dottor Greenson che nessuno è riuscito a cogliere il tema del film, “È sempre possibile cambiare ma non cambiamo”.
La grafomania le viene in soccorso come un amico immaginario a cui confidare segreti nel cuore della notte, prima di attirare l’attenzione del personale medico, chiede dov’è un telefono. Una ragazza, che ha tentato il suicidio più volte, le indica la strada.
Quanta solitudine ci può essere in una persona che ha provato a tagliarsi più volte la gola e le vene? Nell’angoscia del momento potrebbe ricordarle un ragazzo, l’ex soldato incrociato in una delle sue tante domeniche solitarie dalle parti di Union Square.
Scendono quattro lacrime mentre scrive, prima di essere portata dal direttore della clinica: “Lei è malata, è malata da molto tempo”.
Come sua madre, come sua nonna.
“È sempre possibile cambiare ma non cambiamo”.
Uno psichiatra le palpa il seno per controllare che non ci siano noduli, risentita informa il medico che le è già stata fatta una visita completa poco tempo prima. La maledizione di un corpo che sembra avere una volontà propria: trasmette vibrazioni sessuali fin da quando aveva tredici anni, l’aveva capito camminando sulla spiaggia in costume da bagno per la prima volta.
“Puoi fare una fortuna soltanto stando ferma o muovendoti davanti alla cinepresa senza nemmeno recitare”. Le parole di Michael Chekhov risuonano fastidiose e vere come il fischio che accompagna l’acufene.
“Voglio essere un’artista, non un fenomeno erotico da baraccone”.
Fuori dalla finestra dell’ospedale la neve ha coperto ogni cosa e, “tutto è di un verde smorzato”. I colori, le stagioni e la vita paiono sottotono in quel luogo dove le porte hanno una piccola finestrella per controllare i pazienti ogni momento, ma permane quella consapevolezza che nell’impossibilità di raggiungere una condizione di felicità può essere almeno allegra.
Il ruolo di Sugar Kowalczyk le vale un meritatissimo Golden Globe nel 1960; A qualcuno piace caldo è un successo di pubblico e di critica e Marilyn, nonostante l’ennesimo comportamento snervante sul set, per Wilder e per la troupe, riesce a svicolarsi dal solito ruolo della bionda scema per donare al pubblico, la sua vera famiglia, l’immagine di una ragazza tenera, fragile che affronta la vita con tragica ironia.
Le grida delle altre donne nelle loro ‘celle’ bloccano la mano della donna sul foglio, la neve sembra mescolarsi e sporcarsi coi segni di violenza lasciati dai pazienti. Legge Freud, ammazza il tempo impossibilitata a mescolarsi agli altri dopo il primo giorno di ricovero.
I muri bianchi come quelli di un sogno strano fatto nel 1955 quando era scappata a New York da quella grande ‘vena varicosa’, come chiamava lei Los Angeles: un chirurgo, Strasberg, aiutato da un altro medico deve aiutarla, aprirla, guarirla da una malattia senza nome.
La aprono, non trovano nulla, la delusione prende il sopravvento sui due uomini intenti a operarla; una paziente fatta di vuoto completo, quale scopo ha per un uomo di teatro come Strasberg? Disappunto e costernazione, il sipario dovrebbe calare a questo punto ma sono tutti troppo disorientati: c’è segatura dentro la paziente? È una bambola di pezza? Ora si sparge su tutto il pavimento disturbando quel bianco abbacinante che permea la stanza.
Arthur Miller l’aspetta fuori dalla sala operatoria, il capo è chino e appesantito dai troppi pensieri tipo “Cosa accadrà a Marilyn?”, “E alla mia pièce?”, ma non c’è consolazione per un uomo votato all’arte.
“Assassini! Bugiardi!”.
Norma Jean, Roslyn sulla carta e sullo schermo, le sue urla sono come una ferita pulsante capaci di squarciare le fondamenta del creato. Nel deserto del Nevada è di lei, come sempre, che si parla. Stanno girando Gli spostati e coi pugni serrati e le braccia distese lungo ai fianchi, la diva dai capelli color platino riversa tutto il suo dolore sul mondo.
“Macellai! Assassini!”.
Miller scuote il capo, viene rassicurato da telefonate e visite all’ospedale.
Ma chi? Marilyn Monroe? Ha tanto da offrire, il pubblico è tutto il suo mondo, non può esserci dentro di lei solo segatura. Nella sala d’aspetto si rincorrono questi pensieri e domande senza risposta.
La piccola Norma, quella che è stata sballottata da una casa famiglia all’altra, la bimba che faceva il bagno nell’acqua sporca dopo che sei o sette persone si erano lavate. Non tirare lo sciacquone di notte, l’acqua costa, tira l’acqua al mattino. Quando ci sono problemi stai zitta. La seconda settimana del mese c’è l’ispettrice dell’orfanotrofio, deve controllare come stai. Zia Grace chiede come va, tu rispondi che va tutto bene. Fantasticare rende il lavoro più facile. Avere otto anni e innamorarsi di un ragazzino di nome George, nascondersi sull’erba. Il signor Kimmel prega per l’umanità ma ciò non gli ha impedito di abusare di Norma Jean nella sua stanza. Inginocchiarsi durante la messa e raccontare della violenza subita mentre tutti i peccatori si ammassano attorno, e sono così numerosi che la sua stessa preghiera viene schiacciata da mille parole senza voce, non raggiunge il cielo e rimane ancorata alla terra. I pensieri di Marilyn Monroe non si disperdono sul pavimento come la segatura ma rimangono lì, fissi, in quegli occhi vitrei che osservano Strasberg.
2 marzo 1961
“Se insistete a trattarmi come una pazza mi comporterò come una pazza”.
Due uomini e due donne prendendola di peso la portano al settimo piano della clinica. L’ombra gettata sulla sua famiglia dai disturbi mentali acquisisce una consistenza liquida che le passa sotto la pelle, piange silenziosamente mentre a faccia in giù viene trasportata come un sacco di patate. Un’altra notte insonne mina le sue forze, ma ha il tempo, su carta, di spendere un pensiero dolce sul secondo marito Joe DiMaggio; la mente vola alla sera di Natale e sul di lui regalo, una telefonata che ha il sapore di una memoria sbiadita come una cartolina e una visita piacevole e inaspettata.
“Non mi sento di rientrare. Le dispiace guidare ancora un po’?”.
Quella serata del 1951 era iniziata con un po’ di disagio tra i due: i conoscenti della coppia avevano passato il tempo a elogiare le doti del campione sportivo mentre Marilyn si sentiva ancora una volta inadeguata, incapace di decifrare quei modi compiti e i silenzi penetranti. Nel mondo dello spettacolo l’importanza di un uomo è direttamente proporzionale alla sua logorrea. Eppure quella personalità così distante da quella a cui è avvezza l’attrae, non l’allontana.
“È una bella serata per guidare” rispose lei col cuore in gola.
5 marzo 1961
Gli eventi scritti da Marilyn sono accaduti nel febbraio del 1961 ma è nei primi cinque giorni di marzo dello stesso anno, quando esce dal Presbyterian Medical Center della Columbia University, che riesce a buttare tutto su carta quasi a voler esorcizzare quell’incubo ormai concluso. Il ricovero lo definirà un errore e la clinica un luogo privo di umanità.
Ora è libera di abbracciare i progetti futuri in collaborazione con Lee Strasberg e forse con l’amico Marlon Brando. Lontana da New York, poco prima di Natale, passa il tempo a sognare di una casa di produzione indipendente spiegando a Lee, non senza una certa urgenza, quanto fosse essenziale il suo contributo. Lavorare è quello che le consiglia il dottor Greenson. Non ha più tempo di girovagare vicino alla Union Station benché la solitudine si sia acuita con l’avvento della fama. Hollywood è pieno di stelle di latta che vengono spacciate per argento da un ex soldato un po’ cialtrone. Un’orfanella nella spietata città del Cinema quante possibilità ha di diventare una stella? La sua vita, come quelle più grandi, è diventata un mito proprio perché possiede l’ampio respiro che rispecchia l’immensità di quella vasta terra che è l’America. Posa la penna, la sua vita sembra consumarsi nel tempo di una lettera, da questo punto in poi qualcun altro continuerà a scrivere la sua storia. Un dubbio affiora nel suo spirito sempre inquieto e senza pace, “Se qualcuno chiedesse com’ero io, cosa diresti? Cosa direste?”. Poi un sorriso increspa quel bellissimo volto senza età: ricorda la risposta del vecchio amico Truman Capote, “Direi che sei una bellissima bambina”.
Se non siete ancora sazi leggete il nostro articolo su uno dei più grandi maledetti della storia del cinema: River Phoenix