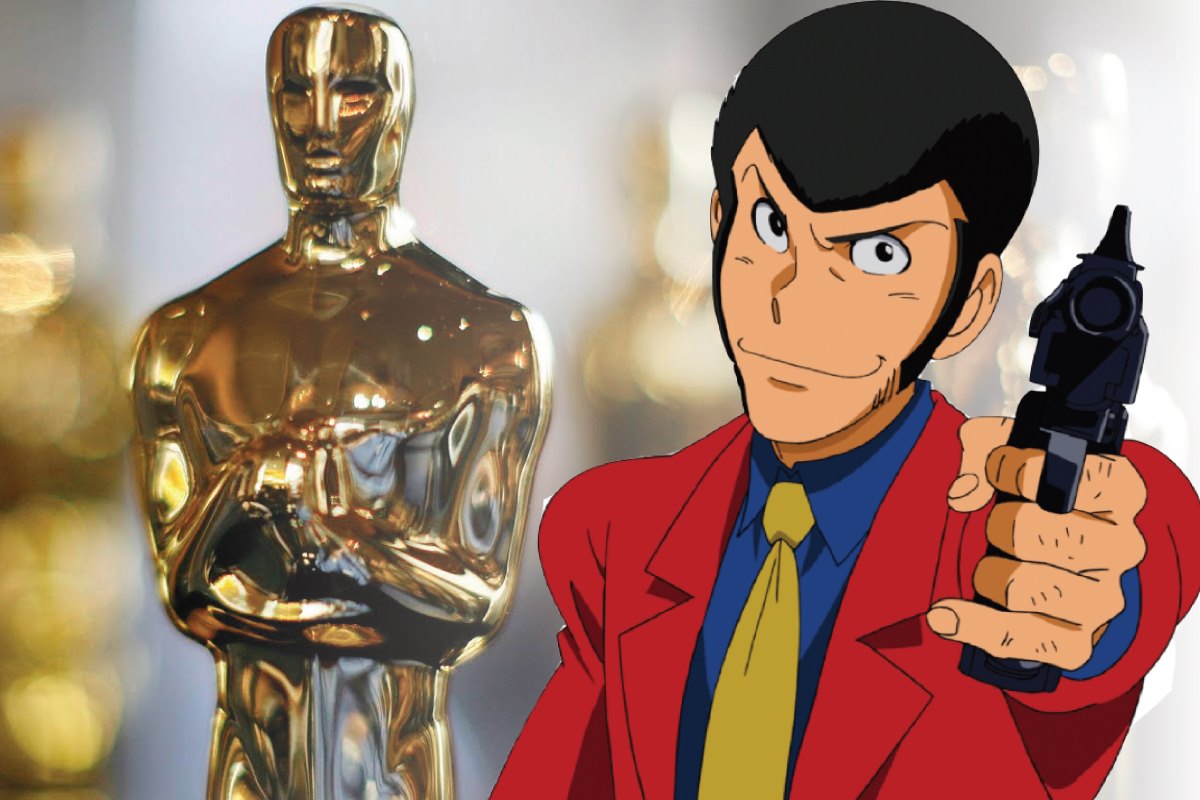Continuano le cronache dalla paroxetina con la parte del dottore.
Il dottore sulla soglia della porta ricordava molto la sagoma di un Alieno venuto dallo spazio per un dottorando in ricerca sperimentale, mentre all’interno dello studio la luce delineava un forte bagliore intorno ai bordi dei suoi vestiti, rendendolo più grosso.
Malgrado i miei occhi fossero attratti come cimici sui panni tesi, entrai con la stessa tenacia con cui i Mccallister si ricordarono del figlio prima di partire.
Deglutii e affrontai la luce. Gli occhi non si abituarono velocemente, tanto che cercai di sedermi arrancando e tastando le poltrone che il medico aveva risistemato frettolosamente prima dell’uscita del Paziente.
Aveva lasciato la finestra aperta, socchiusa. Potevo sentire i suoni claudicanti degli uccelli rumoreggiare sulle grondaie. Lo spiffero faceva muovere la paccottiglia di fogli lasciata sul davanzale e ogni tanto una massa di ossigeno al sapore di carta mi investiva.
Eravamo alti, guardai fuori e intravidi, in fondo, la città eclissare le luci del tramonto.
Queste ultime sagomavano i palazzi come la luce dello studio aveva disegnato i profili del dottore, creando un effetto matriosca.
Stavo meglio.
Smisi di tremare e iniziai a abituarmi alla luce.
Quello che successe dopo fu alquanto particolare.
Mentre il dottore chiudeva la porta e con eccessiva filautia si accertava della sua compostezza,
ebbi, come non si suol dire, una ‘botta di vista’, data probabilmente dall’improvviso riacutizzarsi della vista stessa… e la mia attenzione fu pugnalata da qualcosa. Un quadro.
Questo investì completamente il mio campo visivo e lo conquistò con la forza, saccheggiandolo di ogni ragione e ricchezza logica.
Il quadro si trovava proprio dietro la scrivania del medico e non so se fosse stato appeso lì volontariamente oppure casualmente, fatto sta che aveva su di me un effetto devastante.
La sua posizione era centrale sul muro e, seppur di limitata grandezza, sorbiva su tutti gli oggetti lo stesso effetto che La Gioconda esercita su Le nozze di Cana.
Non c’era cornice e non coglievo l’ombra come se in realtà il quadro fosse il riflesso della parete opposta.
Non ebbi né il coraggio né la forza di voltarmi, ma non mi sbagliavo. Ne ero sicuro.
Di fronte a quello zibaldone artistico le mie memorie sull’arte si erano inginocchiate in un nugolo inconsistente, un purè senza sostanza, un agglomerato anonimo.
Cercai di riavermi setacciando la stanza in cerca di una distorsione fuorviante.
Incrociai lo sguardo intimidatorio del professore; si era seduto di fronte, e adesso articolava i suoi strumenti per certificare la mia presenza nella sua agenda.
Fu peggio.
Mi sentii divampare e bramai di tagliargli la testa per mantenere un contatto con gli occhi del quadro.
Non è facile descrivere cosa rappresentava:
il soggetto era una Donna. L’età era convenzionale; poteva avere 50 anni, ma il trucco la ringiovaniva di almeno 25 anni e l’artista, un maniaco, era riuscito a marcare la chiara volontà della donna di celebrare la sua vittoria contro il tempo. L’aveva distesa e aveva ritratto solo la faccia fino a poco più delle spalle. L’ espressione era attonita, assorta, forse cosciente della sua bellezza, forse impaurita di esser derubata della sua ritrovata giovinezza.
Gli occhi, semichiusi, riflettevano un’espressione a metà tra una fotografia scattata nel momento sbagliato e il prodotto di un orgasmo sincero.
Il colore intorno alle pupille era incerto e fuorviato da una massiccia dose di matita nera che esaltava il contrasto con il rossetto rosso fuoco sulla bocca.
La testa sprofondava in un cuscino, attutita da capelli color grano su cui passava e poggiava una mano, dolcemente, come fosse sabbia. La luce la baciava sulla fronte, seppellendo le ombre fuori dal quadro.
Si intravedeva uno spallino. Apparteneva al reggiseno e scivolava fuori dal quadro, tuffandosi, in prospettiva, sulla spalla del dottore, di fronte.
Trasalii, completamente avvolto nel mistero della bellezza.
“Non so dire se la potenza del bene passasse nella natura del bello, ma attraverso gli occhi l’effluvio del bello rimaneva infiammato e di esso la natura dell’ala si abbeverava.
E la bellezza, dunque, rendeva alata l’anima e le faceva conoscere il tormento dell’amore”.
Mi sentii marionettare prima dai sensi, poi dalla mente e vidi, chiaramente, negli schizzi della tela un significato esplicito e uno nascosto.
Il quadro trasudava la storia di un amore non corrisposto: infatti le linee femminili brillavano di una vivacità che non era propria del vero corpo della donna: insito era il ritocco affettuoso di un uomo, perso nella voglia di attenzioni specifiche, quelle di lei.
Non so distinguere se occorresse intuire o discernere la bellezza, tuttavia non c’era logica. Quest’ultima si suicidava nel riflesso che quella figura suscitava nei miei pensieri.
Mi avevano sempre spiegato che l’artista si distingue dal falso come promotore di un’idea che si distacca da tutto quello che c’è stato prima e aprirà uno squarcio progressista nel contenimento dell’equilibrio. Lo si riconosce in quanto lavora alla luce del sole per creare opere d’arte fini a sé stesse, ma di opulente valore per l’umanità.
Il falsario sottrae l’unicità dell’idea e la duplica, ma non resiste nel lasciare una firma nell’imitazione. Così introduce una sbaffatura, una distorsione, congruente alla maniacalità dell’omicida nel lasciare una traccia per vantarsi del misfatto.
Quello del quadro non era il prodotto di un artista, impossibile.
Ma non era nemmeno il lavoro di un falsario.
Quello era un maniaco. Un malato.
– …Patroclo giusto?- come un tonfo nell’acqua, la voce del dottore rianimò i miei sensi.
Riuscì incredibilmente a farmi riavere. Mi sentivo intorpidito, come se avessi passato gli ultimi mesi a piangere per una donna. Quella Donna.
Mi toccai i capelli nell’intento di disfarmi di quella sensazione spiacevole.
Con la mano passai sotto la nuca e mi asciugai il sudore che si era addentrato, giù, lungo la schiena come un serpente che striscia nell’ombra, per fuggire via.
– Sì!- risposi senza aggiungere altro.
– Non ho molto tempo – mi ferì – Ma ti ascolto. Dimmi pure, cosa ti succede?-
Cominciavo a odiare i suoi imperativi.
Iniziai la mia storia… e anche se credevo che sarebbe dovuta essere una collaborazione di domande e risposte, in realtà fu un monologo.
Ogni tanto riguardavo il quadro e le mie parole si tingevano di amaro, come il sapore di una sigaretta spenta e poi riaccesa; sembrava che la donna mi chiedesse di entrare nelle mie storie, nella mia Malattia.
Mi sentivo Jodie Foster in Sotto Accusa, ma nella versione comica di Vincent Vaughn di Due single a nozze.
Mi fermavo, a tratti, fingendo di pensare, ma in realtà riprendevo fiato.
La mia foga vulcanica di parlare eruttava aria, senza però inglobarne abbastanza e spesso avevo vertigini che mi costringevano a sudare e fermarmi.
Il dottore non se ne accorgeva. Scriveva. Non so cosa, non l’ho mai scoperto.
Alternava sguardi di desiderabilità a momenti di intenso interesse nelle mie parole.
Mentre raccontavo i miei trascorsi incubi, guardavo intorno.
Sbirciai frettolosamente la parete alla mia destra. Gli attestati di lode e le partecipazioni a vari aggiornamenti santificavano il muro adornato con la carta da parati motivo fiorentino.
In cima alla stanza il condizionatore vibrava, voglioso di ghiacciare l’aria.
Il dottore doveva essere fissato con la temperatura ottimale perché puntualmente guardava la spia dell’accensione per accertarsi della sua azione congelante.
Io invece amavo il caldo perché il freddo mi dava brutti pensieri.
Il mio racconto finì e canalizzai tutte le speranze nelle sue parole.
Non ci furono parole. Più veloce della luce stampò un foglio, scritto al computer durante la recitazione della mia parte.
Mi spiegò due o tre punti burocratici sulla fattura e poi… mi mostrò il foglio:
Paroxetina. –
Da lì iniziarono i miei incubi.
Fu tutto buio. La voce cantava: “Everything is gonna be alright”.
Funzionò senza masticarla…