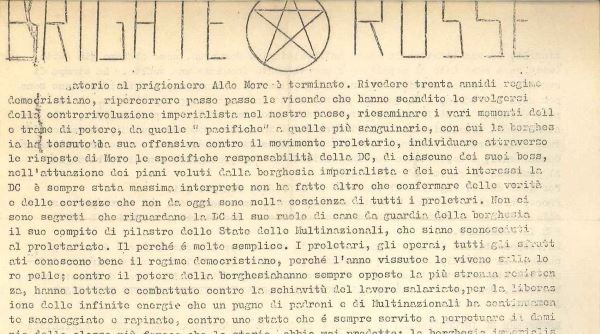Il romanzo di Vasta arricchisce il mosaico che cerca di sondare l'uomo nella Storia grazie alle categorie della Letteratura.
Quando si prende in mano un libro che racconta le vicende delle Brigate Rosse e del sequestro Moro, ci si aspetta di incappare, a un certo punto della narrazione, nella descrizione del corpo della presidente della Dc rannicchiato nel baule di un’auto, così come ci è stato mostrato mille volte sui giornali, in tv, sul web. Eppure, nel primo romanzo di Giorgio Vasta, Il tempo materiale (minimum fax, 2008), pur ambientato nel 1978, non c’è traccia di una delle immagini che hanno segnato la storia del nostro Paese. O meglio, quell’immagine è deformata al punto di restituirle tutta la sua forza traumatica originaria, di cui è stata privata via via che rimbalzava di giornale in giornale, da quarant’anni a questa parte:
“[…] Aldo Moro intirizzito, le braccia piegate strette contro i fianchi, la testa chiusa tra le spalle, le ginocchia contro il petto, l’onorevole esibito, ostentato, innalzato nella sua culla di acciaio inox e offerto a nutrimento sacrificale, a ostia da prendere in bocca e ingoiare senza pensiero, tutta l’Italia e tutti gli italiani, mangiare il presidente della Democrazia Cristiana, fare la comunione, non masticare, deglutire, sentire dentro il sapore di quaresima e di grano, di medicina, e poi guardarsi negli occhi e trovarli luminosi e senza angosce, gli sguardi pieni compatti e onorevoli degli italiani.”
Gli italiani hanno trovato il modo di liberarsi dei loro fantasmi e dei loro peccati, a costo di rimuoverne dalla memoria la componente traumatica. Il romanzo di Giorgio Vasta, invece, li riporta in superficie e va dritto al cuore di una questione essenziale della narrativa contemporanea (e non solo): quale può – o deve – essere lo sguardo della letteratura sulla storia?
Una domanda di illustre tradizione, ma che oggi si sta facendo particolarmente stringente, se consideriamo che molti giovani autori (e lettori) non hanno vissuto le esperienze cruciali della storia del nostro Paese. Siamo ben lontani dal clima descritto da Calvino nella Presentazione al Sentiero dei nidi di ragno, in cui l’autore racconta che
“L’essere usciti da un’esperienza – guerra, guerra civile – che non aveva risparmiato nessuno, stabiliva un’immediatezza di comunicazione tra lo scrittore e il suo pubblico: si era faccia a faccia, alla pari, carichi di storie da raccontare, ognuno aveva avuto la sua, ognuno aveva vissuto vite irregolari drammatiche avventurose, ci si strappava la parola di bocca. “
(I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, Mondadori, Milano 2011, p. V)
Oggi viviamo piuttosto in un’epoca di inesperienza, in cui guerre e violenza sono vissuti tramite i media o, in ogni caso, non sono un fattore che ci accomuna gli uni agli altri, che costituisce un’identità collettiva. Che senso può avere allora un romanzo sugli Anni di Piombo scritto da un autore nato nel 1970, letto da chi non ha mai vissuto quel periodo?
Prima di tutto, per essere certo di poter davvero dire qualcosa, senza limitarsi a riproporre immagini già viste, Vasta si è assicurato di evitare in toto i luoghi comuni, come nel caso del rapimento di Moro. Per farlo ha adottato un punto di vista ben preciso, che, ancora una volta, mi ha fatto pensare al Sentiero dei nidi di ragno: la storia è raccontata da un ragazzino di undici anni, che è al tempo stesso narratore e protagonista della vicenda. L’autore ci mostra il 1978 attraverso lo sguardo di Nimbo, di cui appare chiaro fin da subito il desiderio più urgente: lasciare un segno sulla realtà, infettare l’immagine edulcorata dell’Italia che vede in televisione:
“Il ponte a schiena d’asino di Apecchio, la valle di Visso sparsa sparsa di case chiare. San Ginesio, Gratteri, Pozza di Fassa. […] L’eterna Italia rurale e pastorale tirata su con le pietre grigie tagliate a mano, […] semplice, contadina, i morti che riposano nei cimiteri di paese, la ghiaia sul fondo tra le tombe, gli scricchiolii e l’odore dei gladioli, tra la ghiaia le bacche dei cipressi, il cielo limpido, le rose. Fantasmi del paesaggio, circonvenzioni della percezione nazionale. Il pittoresco, il locale, il premoderno, il genuino. La bella Italia semianalfabeta che per decenza ignora la grammatica.”
Nimbo, al contrario, vede nella grammatica e nel linguaggio un modo per distinguersi da chi lo circonda, per elevarsi al di sopra di coetanei e adulti. Al punto che uno dei suoi ricordi più preziosi è la frase di una maestra che, all’esame orale di quinta elementare, gli aveva poggiato una mano sul petto dicendogli: «Tu sei mitopoietico». La conoscenza profonda del linguaggio serve anche a misurare le parole della Bibbia, che il padre gli legge tutte le sere, e a respingere l’ironia, che Nimbo vede come una forza negativa e opprimente:
“E a me l’ironia fa male. Anzi, la odio. […] Perché ce n’è sempre di più, troppa, la nuova ironia italiana che brilla su tutti i musi, in tutte le frasi, che ogni giorno lotta contro l’ideologia, le divora la testa, e in pochi anni dell’ideologia non resterà più niente, l’ironia sarà la nostra unica risorsa e la nostra sconfitta, la nostra camicia di forza, e staremo tutti nella stessa accordatura ironico-cinica, nel disincanto, prevedendo perfettamente le modalità di innesco della battuta, la tempistica migliore, lo smorzamento improvviso che lascia declinare l’allusione, sempre partecipi e assenti, acutissimi e corrotti: rassegnati.”
Il giovane protagonista e i suoi due compagni, Volo e Raggio, sono affascinati dal linguaggio dei comunicati delle Br: le parole dei terroristi rifiutano l’ironia, sono «tecniche e violente», perché portano con sé il peso delle azioni compiute. Anche il regista Paolo Sorrentino ha compreso a fondo l’inconciliabilità tra ironia e ideologia, se nel film Il Divo fa dire a Giulio Andreotti: «Sai, Mario, una volta mi hanno chiamato a casa. Nessuno ha il mio numero di casa. Mi dissero che mi avrebbero ammazzato il 26 dicembre. Io gli risposi: “Grazie, cosi passerò il santo Natale in pace”. Sono ancora qui. Si fecero scoraggiare da una battuta: queste erano le brigate rosse, gente troppo seriosa».
Nimbo, Volo e Raggio, come le Br, si assumono la responsabilità di agire e fondano una cellula terroristica chiamata NOI:
“Coordinarci durante queste prime azioni di lotta […] ci ha insegnato che noi è la parola in cui coesistono la distruzione del soggetto individuale e l’orgoglio di essere compagni […]. NOI è anche l’acronimo di Nucleo Osceno Italiano: nucleo identifica la solidità; osceno è l’unico tempo che abbia senso vivere; italiano è ciò che ci indigna e ciò in cui siamo immersi.”
Dopo aver appiccato alcuni incendi a scuola e aver fatto esplodere l’auto del preside del loro istituto, i tre giovani decidono di mettere in atto un vero e proprio sequestro. L’obiettivo è Morana, un compagno di classe emarginato, poco intelligente, proveniente da una delle famiglie che Nimbo definisce «dialettali», rimarcando che la differenza tra gli individui passa attraverso la conoscenza e l’uso del linguaggio. Dopo qualche giorno, i tre uccidono Morana, ma non per uno scoppio improvviso di ira o paura. Il suo corpo viene schiacciato con pazienza e metodo, salendogli sul petto, sulla gola, comprimendogli la testa. C’è il desiderio di lasciare un segno, di deformare il frammento di realtà su cui si ha potere:
“Rispondo al cenno di Volo e vado a sedermi sulla pancia, la schiaccio in fondo. Avverto nell’immobilità un residuo di respirazione addominale: aumento la pressione e la cancello. Restiamo così per un tempo che non so calcolare. Sento i nostri odori che si mescolano. Sono forti, buoni. […] Uno mescolato all’altro siamo un nodo. Chiuso nel nodo coviamo un morto. Un morto semplice. Il morto semplice. Non lo coviamo, lo partoriamo: il corpo morto di Morana viene fuori dai nostri corpi vivi. Se il pudore imposto dalla militanza non ce lo proibisse, vorremmo e dovremmo piangere di commozione. Di gioia e di dolore. Perché abbiamo trovato il luogo nel quale tutto si concentra e si rivela. Noi uccidiamo: noi sappiamo uccidere.“
Morana non rappresenta in alcun modo un obiettivo politico, eppure permette a Nimbo di realizzare un desiderio profondo: compiere azioni dall’effetto tangibile e traumatico. È riuscito a infettare quello che lo circonda, come aveva sempre fantasticato di fare, ferendosi col pezzo di fil di ferro arrugginito che porta in tasca. In realtà, questi pensieri non nascono da un semplice desiderio: il nome di battaglia “Nimbo” deriva dall’idea di essere investito di una missione, di avere il dovere di modificare la realtà.
Il problema è che la logica ferrea dell’ideologia e l’inspiegabilità di un’elezione «naturale sovrannaturale», come la definisce il protagonista stesso, difficilmente possono convivere. Quando Volo propone ai compagni di sequestrare Wimbow, la ragazzina di cui Nimbo è innamorato, il rifiuto nasce spontaneo. Nimbo manda all’aria il piano organizzato per rapire la giovane e si ritrova da solo con lei ma, per la prima volta nella sua vita, deve fare i conti con la mancanza del linguaggio, dato che Wimbow è muta. Senza il linguaggio, l’ideologia non si regge e il protagonista può uscire dalla contraddizione di cui si era reso conto da tempo, secondo cui «[…] Stato e Br coincidono. Le loro logiche coincidono. Il loro linguaggio, osservandolo da vicinissimo, coincide. Lo Stato brigatista. La statalizzazione delle Br. La fabbricazione e la distruzione, l’ordine e il disordine. Equilibrare, squilibrare, equilibrare di nuovo».
Per la prima volta dall’inizio del romanzo, Nimbo rinuncia a far rientrare a forza il mondo nelle griglie dell’ideologia, organizzate secondo parole ben soppesate. La realtà fluisce al di fuori degli schemi organizzati del linguaggio, di qualsiasi cosa possa essere definita un’istituzione, ed è possibile perfino essere proiettati fuori dal tempo, la categoria più ineludibile di tutte:
“il presepe della biologia, fatto con il buio siderale che riempie la cavità femminile e con la materia stellare frantumata nello sperma maschile che quando entra nella cavità si disintegra nel nero e crea lo sciame bianco, la stria delle costellazioni luminose, e nel corpo e nel cosmo, nella dolcezza di ogni conflagrare, fa nascere la notte – e ogni figlio è notte e conflagrazione e smarrimento, tempo incarnato, e le generazioni da millenni si chinano sul corpo del tempo e lo guardano e lo immaginano e adorano il suo buio difeso dalle stelle immaginando che nelle cose, oltre all’infinito impulso a permanere, ci sia un fine, e allora al tempo mescolano il linguaggio e la distruzione dei corpi e nel buio creano e disintegrano parole, lo sgretolarsi delle luci.”
Il desiderio di infettare la realtà si trasforma in desiderio di fertilità, al punto che Nimbo dichiara di voler diventare padre, nonostante la sua giovane età.
È così che un momento storico decisivo e, soprattutto, il racconto letterario che ne fa Vasta, diventano un modo per andare al cuore delle nostre contraddizioni e della nostra essenza profonda, che permane nonostante il trascorrere del tempo e i limiti del linguaggio:
«ed è solo adesso, quando nella fabbricazione della nostra notte le stelle esplodono nel nero, che alla fine delle parole comincia il pianto».
*****
Se ti è piaciuto questo articolo leggi anche: La stanza profonda – Riflessioni di maniera intorno all’ultimo libro di Vanni Santoni.