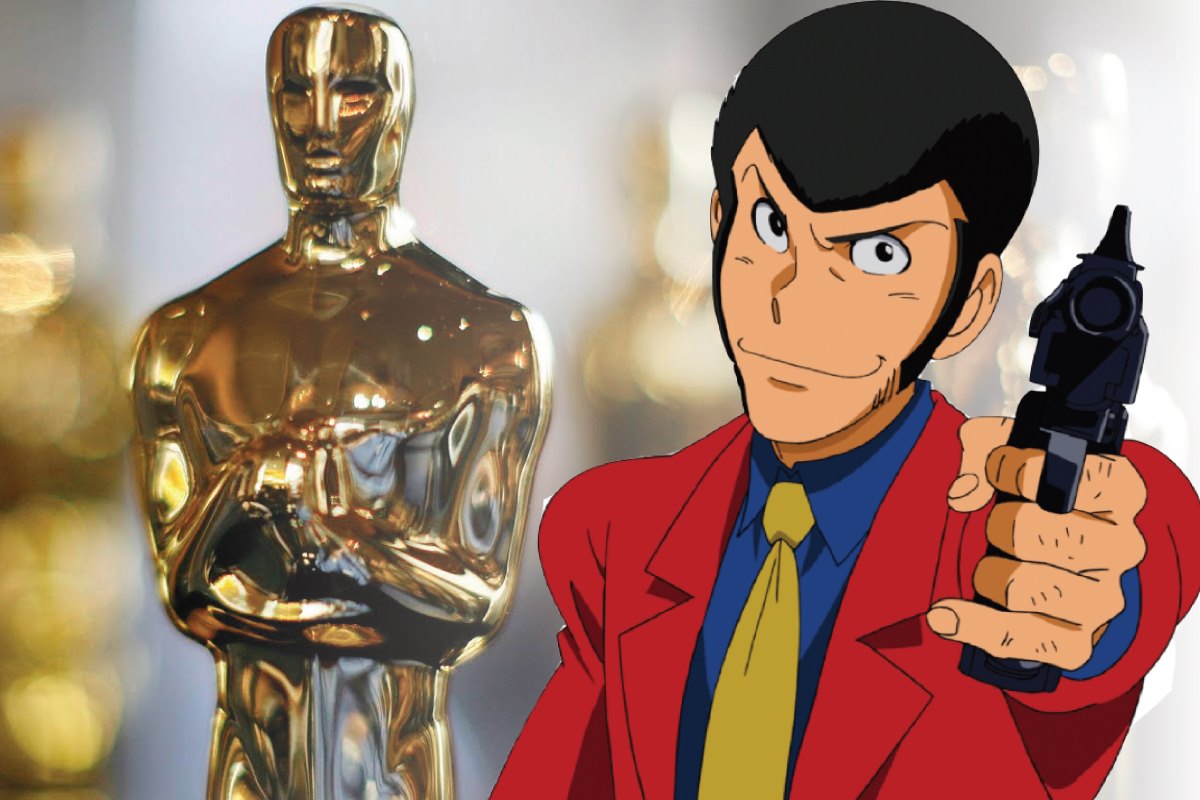Porte Chiuse di Sartre è una pièce teatrale in un solo atto, dove i protagonisti si ritrovano nell'Hotel Inferno, comprendendo i valori di vita e libertà.
“Sono morto troppo presto. Non mi è stato concesso il tempo per compiere i miei atti”. Questa affermazione di Garcin, uno dei protagonisti di Porte Chiuse, pièce in un solo atto (come è giusto e opportuno che sia, visto il tema), racchiude in sé la polpa amara del dramma, ma anche, a suo modo, una materia sarcasticamente molle, come una sorta di chewing-gum masticabile in eterno. L’idea di base architettata da Sartre è semplice e spiazzante: la scena si svolge in un moderno quanto squallido hotel. Non si tarda a intuire che in realtà si tratta della rappresentazione, anzi della sostanza resa visibile e ironicamente abitabile, del più antico e tenace degli incubi: l’Inferno. Senza effetti speciali di fuoco e fiamme e diavoli più o meno danteschi con tanto di forcone e bava alla bocca. Piuttosto un Inferno in versione ergonomica, quasi sobrio, tanto più terribile quanto più credibile, vicino sia dal punto di vista dello spazio che del tempo ai nostri moderni palazzotti superaffollati.
I personaggi ci sono presentati da un cameriere acuto e disincantato, tendente ad un umorismo asprigno. Ci fa fare conoscenza con il già citato Joseph Garcin, giornalista e uomo di lettere di Rio, e con due donne, Estelle Rigault, “donna di mondo” parigina, e Inès Serrano, un’impiegata delle Poste. Tre “poveri diavoli”, in apparenza, che appaiono lì per caso. In realtà, riflettendo un po’, emerge il loro potere di rappresentare, quasi loro malgrado, e forse anche nostro malgrado, l’umanità moderna. C’è la componente intellettuale e quella pratica, l’integrato e l’eversivo, il sognatore e il ragionatore, il cinico e l’idealista. Un po’ del tutto e un po’ del niente che costituisce la base delle infinite potenzialità della vita: le scelte, quelle che fanno la differenza. Alla fine. E appunto, proprio alla fine si trovano i personaggi del dramma. Con divertita e cruda naturalezza veniamo informati che i nostri eroi sono in realtà dei morti. Il loro destino è quello di subire ora un supplizio adeguato. A questo punto, ed è questo uno dei punti cardini della pièce, tenersi addosso le maschere (comiche o tragiche, alla Plauto o alla Pirandello) ha davvero poco senso. Conviene giocare, perché pur sempre di gioco continua a trattarsi, a volto scoperto. Ciascuno mette a nudo se stesso e i propri crimini. Ognuno cerca nella propria sincerità un ponte, qualcosa che sia finalmente in grado di superare le barriere e i fossati, facendolo sentire simile, affine agli altri. Fosse pure nel dolore di una colpa condivisa. L’urlo della coscienza prelude al gesto di tendere le mani per cercare ed offrire un aiuto. Ma il responso di Sartre, prima ancora che quello dei guardiani dell’Hotel-Inferno, è perentorio e impietoso: non c’è possibilità di condivisione né di aiuto reciproco. Anzi, la pena vera, reale, ostinata, nell’Inferno concreto e in quello immaginario, non è negli strumenti di tortura, nei forconi e nei pali incandescenti. “L’enfer, c’est les autres”, scrive Sartre. Gli altri, lo sguardo altrui che illumina implacabilmente le nostre più segrete colpe. La sofferenza corporea è poca cosa, tutto sommato, all’interno delle Porte Chiuse di questo lavoro teatrale. Le ferite più acute e profonde sono quelle morali.
Garcin, giornalista idealista, si chiede se la sua condotta di vita è stata quella di un uomo che ha obbedito alle sue idee fino in fondo, o, semplicemente, quella di un inetto che si è lasciato condurre dalla corrente. La risposta a questo enigma non può darsela da solo. Sarebbe vano oltre che intimamente comico. Non può però rivolgersi a Estella, che lo ama e sarebbe pronta a dargli ragione sempre e comunque, pur di compiacerlo. Chiedere a Estella sarebbe ancora una volta come chiederlo al proprio sé, alla vanità, alla paura, alla menzogna. Non resta che Inès, quindi, molto più lucida e dura. Inès però non può che giocare il ruolo dell’aguzzina. Pur essendo lei stessa colpevole, non ha scelta. La sua sola libertà è quella di contrastare ininterrottamente Garcin, incitandolo a provare a convincerla, a mostrarle che è ed è stato un uomo giusto. Il forcone rovente di Inès sono le parole. La ragione che conficca battuta dopo battuta nel petto di Garcin, e, di ritorno, volta per volta, nel proprio.
Ciascuno interpreta il proprio ruolo. La libertà sognata, il sollievo della confessione, la pace anelata, nascono e muoiono costantemente gli uni negli altri, così come i personaggi si danno reciprocamente vita e morte. Scoprono di aver senso, con la più aspra e paradossale ironia, solo nella convivenza, perfino post mortem. Nell’atto stesso della distruzione, dell’assillo senza tregua. Ciò che dà senso alla vita, e alla libertà, è la condivisione, necessaria e forzata, secondo Sartre. Ciò che dà senso alla libertà, in sostanza, è ciò che la toglie.
Non è una caso forse che nel momento del “colpo di scena”, il solo di una pièce filosofica e meditativa, quello in cui Garcin prova a bussare alla porta del salone e, contro ogni attesa, la vede spalancarsi, accade un fatto del tutto strano: Garcin si trova ad avere via libera, la strada sgombra verso la fuga, la solitudine. Potrebbe darsi alla macchia, libero, incondizionato. Ma si blocca. Resta fermo, impietrito. Bloccato dal terrore come davanti ad un baratro. I tre dannati si ritrovano fatalmente riuniti. Inseparabili, per sempre.
Risuona, agra e tagliente, la frase di Inès: “Si muore sempre troppo presto o troppo tardi. E nonostante ciò la vita è là, conclusa. Il dado è tratto. Bisogna fare le somme. Non si possiede altro che la propria vita”. Già, certo. Ma questa saggezza ineludibile non ha salvato né lei, né il suo paradossale alter ego, Estelle, né, meno che mai, Garcin. Anche di fronte alla via di fuga potenziale, le loro porte sono rimaste chiuse. La sola scelta reale è stata la mancanza di scelta.
Di fronte al meccanismo sottile e stritolante del dramma che ci propone Sartre, il lettore è posto con lucida nitidezza davanti ad un muro. Si prende atto della sua geometrica solidità e consistenza. Il passo ulteriore, istintivo, è quello di cercare un varco. Di qualunque natura, senza badare troppo per il sottile. Può andare bene anche una grata traballante di speranza e banalità: dirsi che, per scoprire che non si è altro che le proprie scelte e le proprie azioni, ciò che si fa, si dice, si pensa e si sente, è bene giocare il più possibile d’anticipo. Prima di arrivare nel parcheggio del fatidico Hotel, prezzi modici e trattamento di mezza pensione. Prima che ci venga ad accogliere all’ingresso qualche cameriere solerte. Tanto spiritoso quanto esoso. Presente e incalzante per l’eternità.