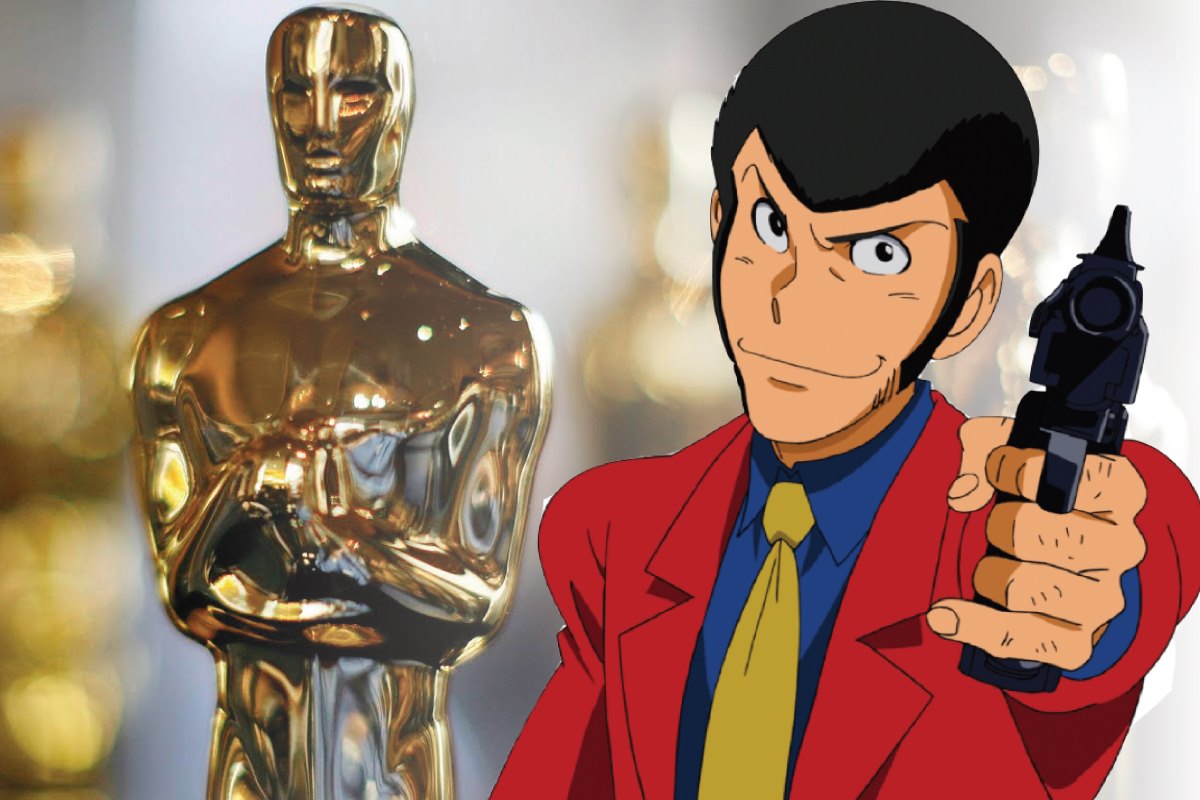Una parabola del nostro mondo triste e sconsolata in cui però la speranza è l’ultima a morire.
Wim Wenders torna sullo schermo dopo tre anni con un altro film documentario. Nel 2011 Pina aveva sconvolto per la potenza delle sue immagini metafisiche. Oggi, con Il sale della terra, Wenders mischia le proprie immagini con quelle del fotografo brasiliano Sebastião Salgado. Ne viene fuori un documentario monumentale che ci mostra il nostro mondo in un bianco e nero che svela un futuro incerto e un presente da cambiare.
Salgado ha girato 26 paesi del mondo, accompagnato dal figlio Juliano Ribeiro – co-regista del film – omaggiando la bellezza del pianeta attraverso i suoi reportages ma anche i lati oscuri, quegli angoli bui in cui domina la miseria, la guerra, la martoriazione della carne e l’avidità dell’uomo. Avidità che ci mostra con sguardo lucido immortalando milioni di minatori della Serra Pelada, la più grande miniera a cielo aperto del mondo, un El Dorado macchiato di sangue, in cui uomini scavano, trasportano chili d’oro sulla schiena e si accatastano gli uni sugli altri come animali, sembra quasi che nell’aria si respiri la legge del “chi si ferma è perduto”. Un luogo senza tempo, o meglio un luogo che il tempo lo attraversa in lungo e in largo. Lo stesso Salgado ci confida il suo stupore davanti alla Storia messa dentro un buco che racchiude milioni di esistenze: “Quando sono arrivato sul ciglio di questo immenso buco, mi si è aperta davanti in una frazione di secondo la storia dell’umanità, la storia della costruzione delle piramidi, la torre di Babele, le miniere di re Salomone”.
Ci mostra i pozzi di petrolio incendiati in Medio Oriente come scenari danteschi, con fiamme alte decine di metri dai contorni ben definiti e in alto un cielo intinto di nero che sa tanto di Apocalisse.
Apocalisse come quella di cui è testimone in Rwanda. Mezzo milione di persone massacrate da armi da fuoco, machete e bastoni chiodati. Un genocidio che nel 1994 dimostra l’ennesima sconfitta dell’uomo sull’uomo. Salgado rimane sconvolto da tutta questa brutalità, decide di fuggire da questo mondo corroso dalla violenza, dal denaro, dalla fame e dall’economia. Decide di andare alla ricerca di posti incontaminati, luoghi in cui l’uomo non ha preso il sopravvento, in cui la natura selvaggia è pura come migliaia di anni fa. Intitola il progetto Genesi, e sarà l’unico modo per ritrovare il contatto con il bello, l’odore dell’aria com’era all’alba dei tempi e soprattutto ritrovare se stesso e la fiducia ormai persa nel genere umano.
Un viaggio durato circa otto anni fra le foreste tropicali dell’Amazzonia, del Congo, dell’Indonesia e della Nuova Guinea, fra i ghiacciai dell’Antartide e fra i deserti dell’Africa e dell’America; tutti mondi in cui natura, animali ed esseri viventi vivono ancora in equilibrio con l’ambiente.
Tornato in Brasile – insieme alla moglie – decide di abbandonare la fotografia per dedicarsi ad un’opera di riforestazione nella propria terra, trasformando in foresta equatoriale una larga area in via di estinzione. Lì ha piantato decine di migliaia di alberi e la natura è tornata a vivere.
La lezione di Salgado ci insegna che il nostro mondo è stato spinto al limite, è malato ma non morto e con l’impegno e il sudore è possibile salvarlo.
Wim Wenders ha dichiarato: “Un fotografo è letteralmente uno che disegna con la luce. Un uomo che descrive e ridisegna il mondo con luci e ombre” e Salgado incarna alla perfezione questa figura divina disegnando una parabola del nostro mondo triste e sconsolata in cui però la speranza è l’ultima a morire.