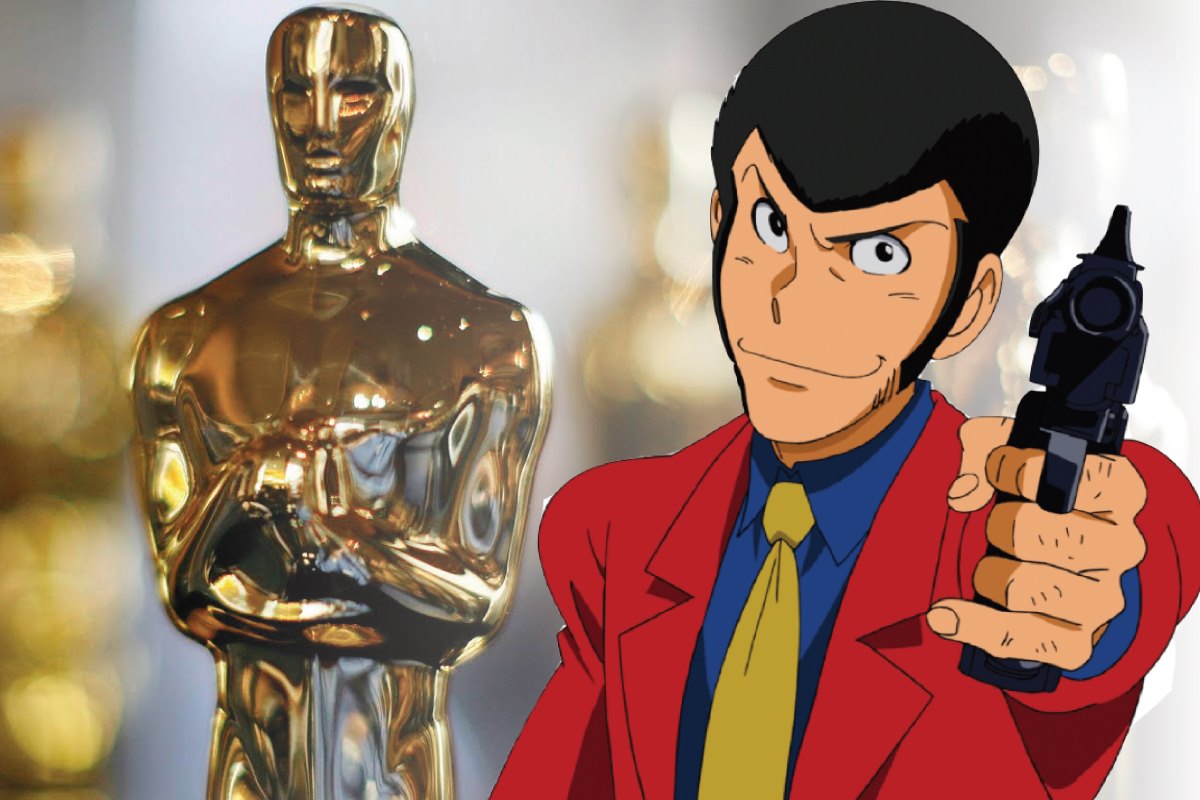Appena restaurato, torna nelle sale il film di Luchino Visconti. Ma l'effetto non è più quello di una volta.
Il 1960 fu un anno fortunato per il cinema italiano per l’uscita nelle sale di tre film che consacrarono a livello mondiale Fellini, Antonioni e Visconti.
Si intitolavano La dolce vita, L’avventura e Rocco e i suoi fratelli. Se, come recita il proverbio, il tempo è veritiero, dobbiamo constatare che dopo oltre mezzo secolo l’ideale sfida fra le tre pellicole l’ha vinta di gran lunga La dolce vita.
Ce ne dà parziale conferma l’ennesima visione di Rocco e i suoi fratelli propiziata dal restauro effettuato dalla Cineteca di Bologna in collaborazione con Titanus, Rai Cinema, The Film Foundation di Martin Scorsese e Gucci.
Rivisto periodicamente nel corso del tempo, il film di Visconti ha mano a mano perso lo smalto iniziale, la forza dirompente del suo debutto quando sbalordì pubblico e critica per l’impietosa analisi del cambiamento antropologico in corso nella nostra penisola fra la fine degli anni Cinquanta e l’avvio dei rampanti anni Sessanta, quelli del disordinato e sguaiato – ma vitalissimo – boom economico.
Lo sradicamento dalle campagne, l’inurbamento, la motorizzazione di massa, gli albori dell’emancipazione femminile, la corsa all’escalation sociale attraverso i primi status symbol (la Vespa, la Lambretta e poi la Cinquecento, la Seicento, la Millecento e parallelamente il frigorifero, la lavatrice, il televisore) raggiunti grazie alle prime conquiste salariali di proletari asserviti alle catene di montaggio, piccolo borghesi trasformati in diligenti bancari, madame Bovary di provincia ammaliate dal richiamo del mondo dello spettacolo, avventurieri pronti a diventare rampanti imprenditori grazie a uno Stato oltremodo permissivo.
E Luchino Visconti, il Conte Rosso, tutto questo lo aveva capito e lo aveva voluto mettere in un film che scrivesse definitivamente la parola fine al neorealismo già da cinque o sei anni in rottamazione davanti all’inesorabile incedere del neorealismo rosa dalle cui ceneri di lì a poco sarebbe nata la commedia all’italiana.
Alla quale Visconti non avrebbe potuto convertirsi: troppo nobile e troppo comunista per celebrare il trionfo sullo schermo della piccola, media e grande borghesia italiana. Non l’avrebbe saputa raccontare come invece, di lì a tre anni, avrebbe mirabilmente fatto con Il Gattopardo filmando l’ideale passaggio di consegne del potere economico dalla sua classe, la nobiltà, alla nuova classe egemone, la borghesia.
Dopo undici lustri, rileggere Rocco e i suoi fratelli fa lo stesso effetto che sfogliare un vecchio libro scolastico di inizio secolo quando si raccontava una prima guerra mondiale come allora si pensava, e si voleva si pensasse, che fosse stata.
Il film di Visconti, ma anche di Suso Cecchi D’amico e di Pratolini (oltre ad altri autori), dà proprio questa sensazione di obsolescenza; le tesi che sostiene e i luoghi comuni che propone sono stati in gran parte polverizzati dal passare dei decenni: la prostituta che lotta per redimersi ma che viene risucchiata dal gorgo del male, i fratelli buoni che si integrano grazie alla fabbrica diventando diligenti soldatini-operai che sembrano usciti pari pari dalle pagine di un romanzo di Pratolini, il fratello buono che si perde perché sedotto dal luccicante e perverso richiamo della società dei consumi e via stereotipando.
Il finale da tragedia greca con l’immancabile riscatto dei buoni nei confronti dei cattivi ha l’amaro sapore dei film matarazziani tanto amati dal pubblico quanto disprezzati dalla critica. Che, ricordiamolo solo per la cronaca, all’epoca aveva una sola ed unica declinazione che imponeva una lettura classista delle opere cinematografiche.
Rimangono intatte le lodevoli doti positive del film: accurata scelta degli artisti, ambientazioni in calzante stile neorealista, recitazione di impianto teatrale ma – soprattutto nella prima parte – perfettamente calata nella finzione cinematografica, musiche e fotografia in equilibrato mélange con i contenuti.