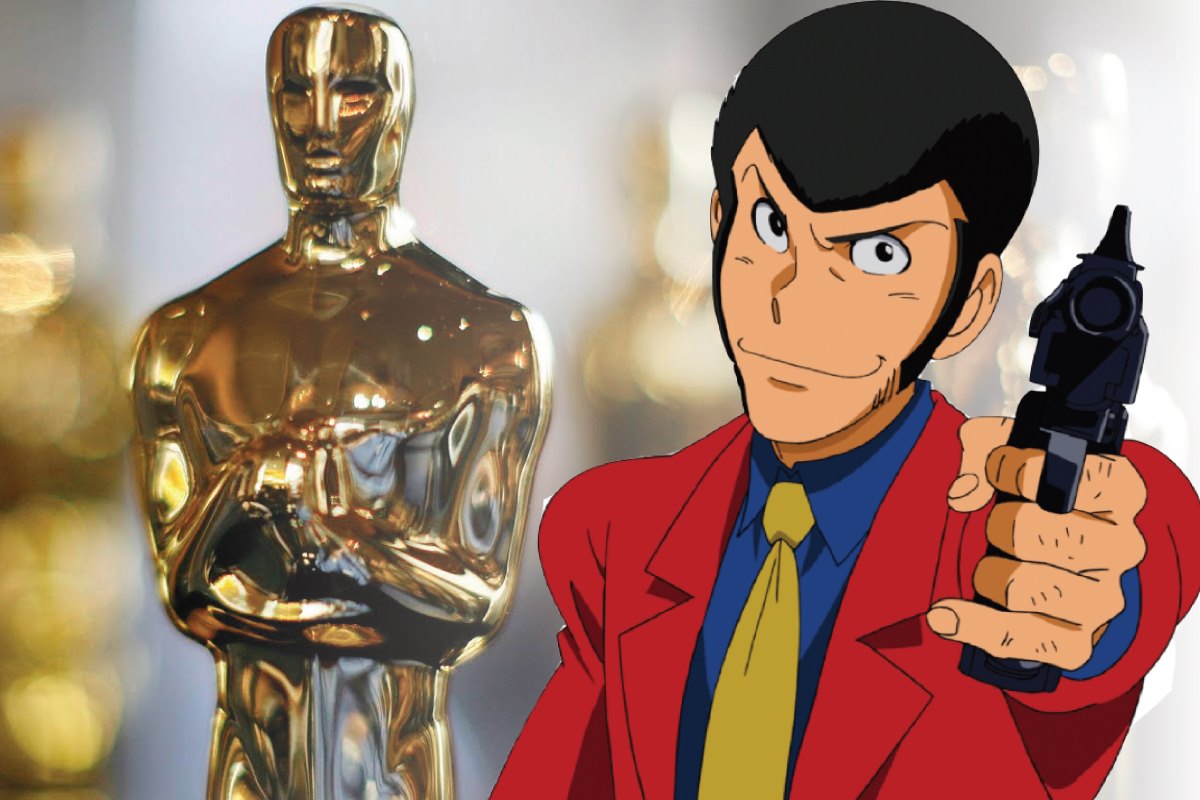Il 18 maggio del 1980 Ian Curtis si toglieva tragicamente la vita. Noi abbiamo deciso di ricordarlo nella sua eternità.
“Coldest summer bank holiday in the last 50 years”. Alle 3 del pomeriggio del 25 agosto di due anni fa il termometro segnava 13 gradi. Nessuna svista, era agosto, e l’Evening News lo sottolineava a caratteri cubitali da un chiosco di giornali del Northern Quarter, a Manchester. Il vecchio adagio per cui Oltremanica può succedere di vivere le quattro stagioni in un solo giorno quella volta non fu valido: faceva freddo, tanto freddo sotto un cielo cinicamente terso, e non smise mai di farlo.
Non pensai nemmeno per un singolo momento che si trattasse di un caso. Di lì a poco infatti, un treno della CrossCountry mi avrebbe portato a Macclesfield, cittadina certamente non ridente distante una ventina di miglia a sud di Manchester. Era il mio pellegrinaggio nei luoghi di Ian Curtis, cantante e paroliere dei Joy Division, ultimo erede di quella tradizione di eroi romantici il cui capostipite è rintracciabile in Thomas Chatterton, menti geniali per le quali il mondo reale va troppo lento rispetto alla propria sensibilità. Quei venti minuti di treno attraverso la campagna del Chesire furono tutti un unico, lunghissimo brivido. Quel freddo eccezionale era una metafora di come mi sentivo dentro, era la natura che beffardamente si faceva gioco delle mie sensazioni nell’approssimarsi dell’approccio con il mito.
Ian Kevin Curtis morì suicida il 18 maggio del 1980, impiccandosi ad una rastrelliera in cui la moglie Deborah stendeva i panni nella cucina della casa al 77 di Barton Street (che ora pare essere destinata a museo, non senza il disappunto dei fans) prima tappa del mio viaggio mistico.
Scriveva Herman Hesse ne ‘Il lupo della steppa’: “Il suicida ha questo di caratteristico: egli sente il suo io […] come un germe della natura particolarmente pericoloso, ambiguo e minacciato, si reputa sempre molto esposto e in pericolo, come stesse sopra una punta di roccia sottilissima dove basta una piccola spinta esterna o una minima debolezza interna per farlo precipitare nel vuoto. Di questa sorta di uomini si può dire che il suicidio è per loro la qualità di morte più probabile”. Sono state dette tante cose di Ian, e probabilmente ai posteri è stata tramandata un’immagine filtrata e per certi versi stereotipata. Sicuro è che si trovasse realmente, negli ultimi mesi della sua vita, sopra quella punta di roccia sottilissima. Ma come ci era finito?
L’epilessia, certo. Il “grande male” che lo aveva tanto martoriato psicologicamente da non andare a letto, spesso, prima che arrivasse la crisi, per paura di poterla avere nel sonno. Ian non accettò mai di essere malato. Ebbe il primo attacco il 27 dicembre del 1978 di ritorno da Londra, dopo un concerto all’Hope and Anchor. E’ comunque da sfatare il mito dell’”epilepsy dance”, ovvero la teoria secondo la quale il celebre modo compulsivo di stare sul palco di Ian fosse ispirato alla sua malattia: la stessa moglie Deborah racconta di come lo avesse visto ballare in quel modo già il giorno del proprio matrimonio, il 23 agosto 1975, ovvero più di 3 anni prima di quando si manifestò la malattia. Quel modo di muoversi, così scattoso, inelegante e nevrotico non era studiato: era semplicemente l’esplicarsi fisico del modo psichico con il quale Ian sentiva e viveva la musica.
Altro mito da sfatare: Ian Curtis non era sempre quella persona cupa, misteriosa e imbronciata che ci hanno detto essere, nonostante si contino sulle dita di una mano le testimonianze fotografiche di una risata, o di un sorriso. Peter Hook ricorda i giorni delle sessioni di registrazioni di Closer, proprio nei mesi antecedenti al suicidio, come una sequela di scherzi e burla da parte di Ian. Era pur sempre un ragazzone del nord Inghilterra: spavaldo e pungente, lo stesso che diede del “fuckin’ bastard” a Tony Wilson per far sì che notasse i Joy Division. Ma questa maschera con cui provava a nascondere la sua depressione era però anche un riaffiorare della sua indole più bambinesca, quella che non l’ha mai abbandonato e quella che probabilmente l’ha portato alla depressione stessa prima e alla decisione di mettere fine alla sua vita poi.
Perchè Ian era un bambino che non è mai riuscito a crescere. Totalmente privo di senso pratico, noncurante delle questioni economiche, incapace di gestire i soldi (visse in ristrettezze economiche anche dopo l’uscita di Unknown Pleasures: quel poco denaro che aveva lo spendeva in sigarette e birra, non badando alle reali necessità a cui un padre di famiglia dovrebbe badare) e anche di cambiare una lampadina perché ovvio, non è compito dei bambini, si scontrò impietosamente con le difficoltà della vita adulta. Per Ian il matrimonio con Deborah fu un gioco. Avere una figlia, Natalie, fu un gioco.
Ian si rese conto di non poter giocare per sempre quando, il 16 ottobre 1979, durante un concerto al Plan K (un bizzarro zuccherificio trasformato in centro culturale) di Bruxelles, conobbe Annik Honorè, diplomatica belga con vezzi da giornalista, probabilmente musa di ‘Love Will Tear Us Apart‘. Se Deborah aveva rappresentato l’amore genuino, semplice e cortese per una ragazza di provincia, Annik era evasione, fascino misterioso: in pratica l’opposto. Se ne innamorò subito, e fu l’inizio dei suoi mali. Da un lato, perché non riusciva ad accettare l’idea di non amare più la donna che aveva amato sin da quando si erano conosciuti al liceo, quella che aveva tenuto stretta a sé sfociando spesso addirittura in una gelosia morbosa e ingiustificata (alla festa di matrimonio versò una birra addosso ad uno zio di Debbie, reo di ballare con la sposina!). Dall’altro, perché allontanandosi da Deborah, Ian si allontanò dalla realtà, dalla persona che lo teneva a bada e che a lui badava, appunto, talvolta come un bambino.
Ceremony live alla Birmingham University, 2 maggio 1980: l’ultimo concerto dei Joy Division
Ian tentò per la prima volta il suicidio il 7 aprile 1980, con un’overdose di fenobarbital presa in tempo dai medici. I Joy Division tennero il loro ultimo concerto il 2 maggio a Birmingham. Il 20 maggio sarebbero dovuti partire per il loro primo tour americano, ma era troppo tardi: Ian aveva deciso di morire, sapeva che non avrebbe mai preso quell’aereo per gli States.
Di Macclesfield mi ha colpito la sua semplicità, la naturalezza con la quale riesce a rendere terreno e comune il mito. Sembra quasi un paese ignaro di aver avuto un abitante così illustre, così poco terreno. Anche la lapide di Ian, un mattoncino di cemento che sbuca a malapena da terra nel cimitero vittoriano di Prestbury Road, è circondata da oggetti normali lasciati dai fans: un paio di portacandele senza candele, qualche foto e dei fiori, una sigaretta intera inzuppata di pioggia, monete, braccialetti e addirittura un biglietto dell’autobus. “Touching from a distance”, come il titolo della biografia scritta dalla moglie Deborah.
Un antico detto inglese recita: “By all means maintain an open mind, but not so open that your brain falls out”, ovvero “mantieni ad ogni costo una mente aperta, ma non così aperta che il tuo cervello caschi fuori”. Ecco, la mente di Ian Curtis era troppo aperta per contenere un cervello così brillante.