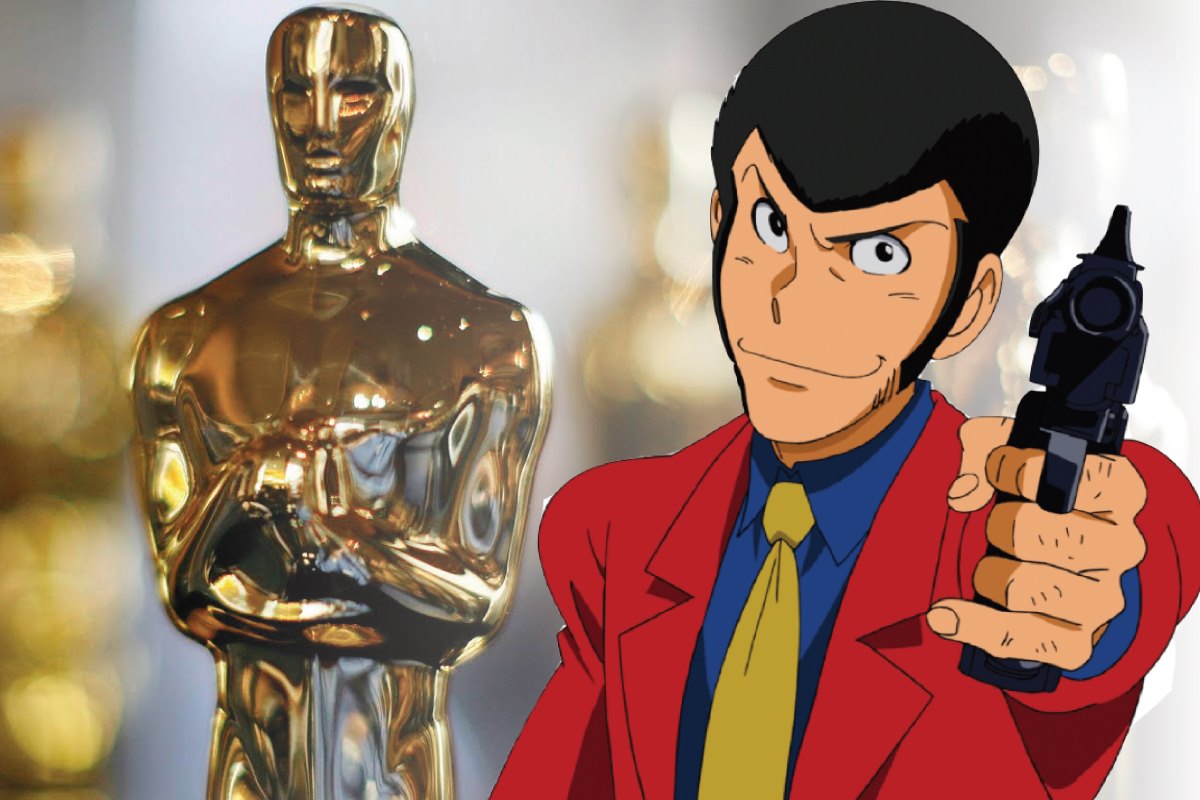8 Ottobre. Qua a Londra l’autunno ulula, e frotte di umanità marciano fra le strade bagnate come un esercito plumbeo. Non è l’aria gelata che mi sferza il viso il più delle volte, ma la sciarpa maldestra di qualche passante che mi sorpassa frettolosa. Danzo fra le pozzanghere raggomitolata nella mia giacca di jeans, mani in tasca, testa bassa. KOKO. “Any spare ticket for Caribou?” – rimbalza nel frastuono del traffico. Imbocco finalmente l’ingresso. Un lieve tepore mi avvolge, e intorno a me un trionfo di sfarzo teatrale risplende fra le pieghe della luce. Tutto d’un tratto, per magia quel gelo che sembra ristagnare nelle migliaia di vite che mi circondano si è dissolto, e ha lasciato il posto a un’empatia magnifica che pochi luoghi riescono a generare: una folla incantata si prepara come ad assistere ad un sacro rito, non c’è confusione, solo un sottile brusio di trepidazione e un’eccitazione palpabile che profuma l’aria.
Sono le 20 e si presenta sul palco Jessy Lanza. Minimale ed elegante, si impone col peso di una sacerdotessa, e con gentile sensualità assurge a gran cerimoniera per questo rituale. La sua esibizione è intensa, concentrata, e catalizza con forza centripeta l’attenzione del pubblico, che ne gode in religioso silenzio. Solo qualche sospiro si perde, sovrastato da un synth potente ma che non si spalanca mai: la signora di Hamilton, Ontario – nientemeno che Hyperdub Records – tiene il suono fra le sue mani e lo plasma, attingendo a sonorità R&B e soul che si avvinghiano a poderose basi electro, talvolta in ritmati pezzi dance, talvolta in più intimi segreti sussurrati all’orecchio.
Lanza cede il suo posto. Di fronte al palco vuoto cresce l’attesa, l’aria è elettrica, surriscaldata, si avverte un raccoglimento estatico. Ed ecco che Caribou fa il suo ingresso in scena: il quartetto si presenta sorridente, cordiale come sempre col pubblico, genuinamente felice di trovarsi a proporre la sua nuova creatura, Our Love, uscita da appena due giorni, in un locale storico come il KOKO di Londra. L’outfit è rigorosamente sobrio, domina incontrastato il bianco, un colore che racchiude in sé tutta la potenza e la luce del suono della band, che letteralmente esplode e risuona maestoso tra le alte mura della sala con Our Love, il pezzo che non solo dà il nome all’album, ma che è senza alcun dubbio programmatico per l’uomo dietro il synth, all’anagrafe Daniel Snaith: l’intero set si rivela una possente manifestazione d’amore, amore per la musica, amore per i fans che sembrano trasportati in un’orgia estatica di suoni, amore per l’amore. L’amore è la dimensione entro cui si svolge questa primavera, questo florilegio che include per la gran parte i nuovi brani, tra cui spicca Can’t Do Without You, che col suo loop si trascina in crescendo fino a sbocciare, magnifica eppure fragile. Non mancano di certo le perle che hanno reso l’ex Manitoba uno dei massimi rappresentanti dell’elettronica contemporanea, come l’intramontabile Odessa, su cui la folla si scatena come un fiume in piena, e Jamelia, entrambe estratte da Swim (2010). Alle spalle della band la cover dell’album, in tutto il suo splendore di colori, su cui si stagliano le luci come lampi, in un’incantevole gioco di riflessi cangianti. Il ritmo serrato, ma assolutamente fluido, si interrompe di colpo per invitare di nuovo sul palco Lanza: sacerdote e sacerdotessa si uniscono per una delicata e impalpabile Second Chance, in una perfetta armonia di accenni vocali e vigorose tessiture melodiche.
Quando la band lascia il palco nessuno si muove. Sappiamo tutti che il rituale ha bisogno di un gran finale. E questo non tarda ad arrivare. Una quanto mai potente e luminosa Sun, che sembra eterna come eterno è l’universo, spalancata su un abisso accecante, trafigge gli adepti, rendendoli ad un tempo inerti e invincibili.
Le luci si spengono. Come tanti soldatini usciamo ordinati dalla sala, e attraversata quella porta torniamo alla nostra grigia e umida realtà, purtuttavia consapevoli che fra il rosso di quelle pareti e fra quei candelabri siamo stati partecipi di qualcosa di più grande.