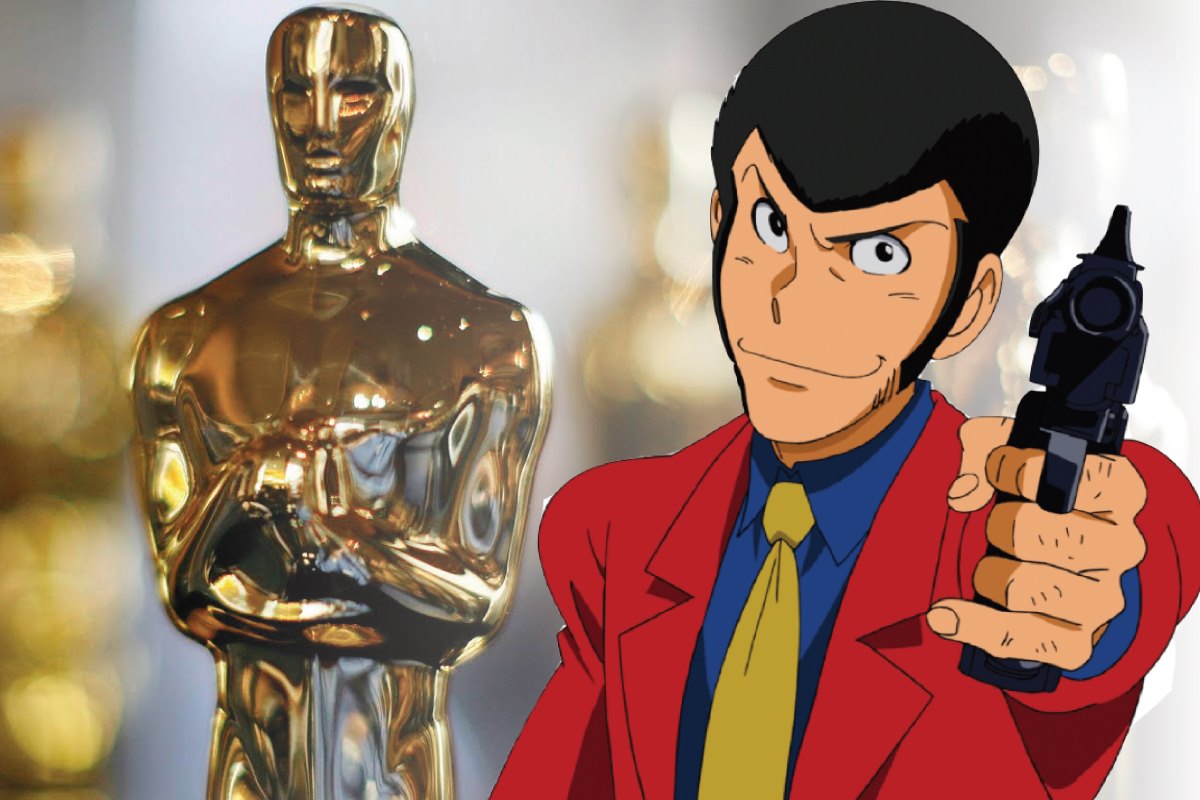Torna l’elegia delle ballate esistenziali dei Sophia
Dopo sette anni, i Sophia son tornati. Era lecito non aspettarsi da loro l’album dell’anno o chissà quale novità rispetto al loro repertorio, ma, con fiducia, quel tanto di consueta onestà e qualcosa di riconoscibile. La band inglese di Robin Proper-Sheppard (leader indiscusso, nato americano ma nomade in Europa) è andata ben oltre le aspettative, perché con As We Make Our Way (Unknown Harbours) consegna un ritorno veramente gradito, addirittura superiore al precedente There Are No Goodbyes. La proposta non varia, rimane quella intima e personale, fatta di testi malinconici, meste atmosfere sad-folk-indie-rock nobilitate dal timbro vocale, dall’elegia degli accordi acustici e in qualche caso degli eleganti arrangiamenti orchestrali. Già nel 1998, con The Infinite Circle, secondo album e forse ad oggi il loro migliore, suonavano così:
I Sophia del 2016 aprono invece con Unknown Harbours, breve e struggente, un refrain strumentale fatto di rintocchi minimali di pianoforte, quasi un richiamo, un appello all’adunanza per tutti i loro fans dalle anime inquiete. Una scelta coraggiosa per il mondo usa e getta Spotify, dove si rischia di giocarsi tutto con i primi secondi del primo pezzo. Si procede poi in territori interiori e musicali più consueti, che siano questi gli aspri reverberi noise di Resisting, le tradizionali ballate esistenziali di The Drifter e Don’t Ask o le dolci note di Baby, Hold On, dedicata alla figlia, dove si parla anche di viaggi in Italia. Conferme dunque, dove trova spazio anche un motivo più orecchiabile che si fissa immediatamente come California, “una canzone su un posto che non sento più mio”. Insieme all’overture strumentale, i momenti migliori del lotto sono però concentrati nella seconda parte dell’album. St. Tropez/The Hustel equivale per i fans della prim’ora ad una vera e propria madeleine proustiana, un tuffo al cuore, dato che rimanda direttamente alle potenti sonorità elettriche dei The God Machine, sottovalutata band di culto californiana prodotta dalla Fiction nonché prima formazione di Robin Proper-Sheppard. Su di loro urge una digressione, non provocatoria, parzialissima ma assolutamente doverosa per chi scrive: nonostante la concorrenza del periodo fosse fortemente valida (post grunge, elettronica, alternative metal, brit pop, post rock…) è bene ricordare come le loro due uniche opere d’arte, Scenes from the Second Storey del 1993 e One Last Laught In A Place Of Dying del 1994, siano state le gemme più splendenti degli anni 90, capolavori assoluti capaci di riassumere, in maniera potente e apocalittica, la varietà del loro tempo. Riconoscibili per il loro sound enfatico e catartico, ma allo stesso tempo poco collocabili per un sincretismo tale da farli sfuggire alle etichette (che pregio! che condanna!), i The God Machine hanno creato con i fans un intimo legame antico, un senso di appartenenza ereditario sul quale ancora oggi i Sophia possono contare, seppur siano stati sempre pochi i punti di contatto nello stile.
Un altro tra i migliori momenti dell’album è You Say It’s Alright, dove inaspettatamente è di scena l’elettronica, con un loop circolare sopra il quale si ripete solo il mantra “You say it’s alright, but I know it’s not alright at all”, frase che ben riassume la filosophia del gruppo. La degna chiusura di questo bel ritorno tocca invece al crescendo di It’s Easy To Be Lonely, un pezzo elevato dal violino, malinconico e di grande pathos emotivo. Ci mancavi Robin.