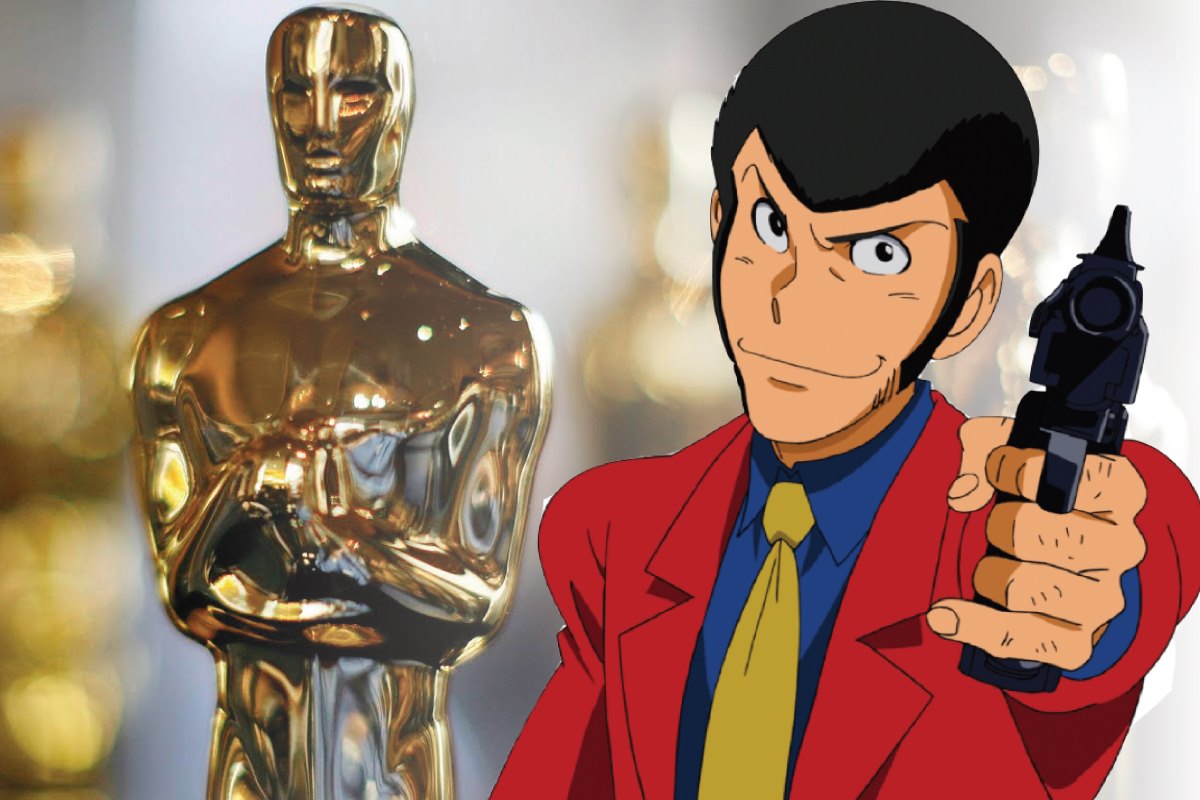Che ne sarà della crisi del digitale?
Con l’avvento dell’era digitale, l’industria della produzione mediatica è stata stravolta e il suo modus operandi radicalmente alterato a causa dei passi avanti mossi dalla tecnologia e dalla inarrestabile diffusione di internet e dell’accesso a questo. Tali cambiamenti hanno avuto delle implicazioni ben più tangibili dell’espansione del cloud: molte compagnie di media si sono viste obbligate a chiudere o a rivedere consistentemente l’organizzazione interna, come per esempio riportano il Digital News Report 2015 della Reuters.
L’industria del giornalismo digitale, dopo le performance brillanti di inizio anni 2000, è entrata in una profonda crisi che ha spinto molti osservatori e studiosi a porsi domande sulle sorti del suo futuro e ad avanzare proposte e idee per nuovi modelli di business – una delle ultime pubblicazioni più commentate in merito è “Sauver le médias” di Julia Cagé, harvardiana compagna di Thomas Piketty.
Abbiamo contattato Nicola Bruno, fondatore di Effecinque, autore di “La Scimmia che Vinse il Pulitzer” e Journalist Fellow al Reuters Institute for the Study of Journalism, per parlare con lui delle possibili evoluzioni future del giornalismo online e della sostenibilità di questo.
il Cartello: Ho trovato molto interessante un parallelismo proposto nell’ultimo report AGCOM che suggerisce che la natura della news (intesa come bene di consumo) è cambiata a causa del progresso tecnologico, ed è ora considerabile come un bene pubblico (ovvero un bene dal cui consumo non è possibile escludere gli altri e il cui consumo da parte di un’altra persona non ne diminuisce la possibilità di consumo da parte di altre). L’ho trovato interessante in quanto molti beni pubblici sono gestiti e garantiti da un intervento statale – finanziato dai cittadini con le tasse. Ciò che complica le cose nel caso dell’informazione però è che lo stato si deve adoperare per garantire libertà di espressione ad un “watchdog” (il mondo media appunto), nonostante l’assenza di incentivi a farlo. Cosa ne pensi? Si può considerare davvero la (nuova) informazione un bene pubblico?
Nicola Bruno: In Europa c’è una lunga tradizione di aiuti statali a stampa e TV: si pensi a Italia, Francia, Germania, Regno Unito; ma anche ai molti paesi scandinavi (tra cui la Finlandia, che è il paese più generoso da questo punto di vista) che nel tempo hanno messo a punto diversi meccanismi di finanziamento pubblico.
Il tema è molto delicato, dal momento che il giornalismo di qualità è indispensabile per le nostre democrazie. Ed è quindi auspicabile un intervento pubblico per migliorare la sua qualità (oltre che per garantirne la sopravvivenza). Al tempo stesso, però, va riconosciuto come non sempre i finanziamenti pubblici abbiano garantito un effettivo miglioramento della qualità giornalistica. In Italia, ad esempio, il finanziamento è stato spesso politicizzato (si pensi alle testate organo dei mini-gruppi parlamentari), facendone quindi uno strumento di propaganda o informazioni di parte. O, ancora, non tutte le TV pubbliche finanziate dallo Stato brillano per indipendenza e autorevolezza.
Gli aiuti di stato possono essere determinanti (insieme ad altri strumenti) per garantire il giornalismo di qualità, ma come sottolineano alcuni studi del Reuters Institute devono avere caratteristiche più innovative rispetto agli attuali finanziamenti a pioggia. Per questo motivo, secondo gli esperti, bisognerebbe 1) legare i finanziamenti al raggiungimento di obiettivi quantificabili; 2) preferire quelli indiretti (esenzione da tasse, etc.) a quelli diretti; 3) supportare solo i processi di innovazione e trasformazione (non i finanziamenti a vita – andando così a sconfiggere il fenomeno delle testate che nascono ed esistono solo finché ci sono i finanziamenti e poi non hanno un effettivo modello di business).
Insomma, senza prendere facili parti pro-contro, resta cruciale la questione del management degli aiuti.
ilC: Julia Cagè, per quanto più interessata al salvataggio della stampa cartacea, propone un modello ibrido ad azionariato diffuso con quote non superiori al 10% supportato in primis dalla rispettiva community di lettori – in pratica una sorta di crowdfunding in grande che presuppone una natura non profit di molte testate. Quanto della sua teorizzazione è realmente applicabile a un contesto reale? Non profit e giornalismo di qualità possono andare d’accordo?
NB: Non ho ancora letto il saggio di Julia Cagé per intero, ma solo qualche estratto. Della sua proposta mi piace l’approccio positivo e costruttivo al problema della crisi della carta stampata. Al tempo stesso, però, condivido alcune delle critiche al suo discorso. La sua ricetta sembra voler riproporre come innovativi modelli come quelli di The Guardian che da un lato rappresentano un’eccellenza giornalistica, ma dall’altro stanno anche attraversando una forte crisi finanziaria. Basti pensare che negli ultimi dieci anni il Guardian ha bruciato oltre 420 milioni di euro. Difficile pensare che questa strada possa essere sostenibile e replicabile.
ilC: Vi è un gap tra progresso tecnologico e la capacità di adattamento dei lettori a questo. Nonostante i trend europei mostrino come i digital readers continuino a crescere, la fonte primaria di introiti pubblicitari è quella della carta. La difficoltà dunque, non è solo dal punto di vista dell’individuazione di nuovi modelli di business che si adattino alla mutata realtà ma, piuttosto, lo scoglio grosso è quello di indurre un cambiamento comportamentale dei lettori in grado di far si che l’elemento “community” o quello del “finanziamento bottom-up” o quello dei “paywall” si normalizzi e diventi, appunto, un “nuovo modello”. Che ne pensi? Ha senso parlare di un unico business model, o chi dirige un’azienda di media deve prima guardare alla sua audience e modellare una offerta ad hoc su questa?
NB: In questo momento di transizione e di ristrutturazione dell’ecosistema dell’informazione, i modelli che possono funzionare di più sono proprio quelli puntano sulla diversificazione. Il che non significa provare di tutto di più (un po’ di carta, un po’ di web, un po’ di tv, un po’ di pubblicità, un po’ di paywall), ma prima lavorare sulla propria community di riferimento e poi individuare i suoi reali bisogni.
Credo che quanto più i media generalisti investono su contenuti a basso costo (e altrettanto scarsi ritorni di fidelizzazione sul lungo periodo), tanto più che la capacità di saper intercettare e soddisfare i bisogni dei propri lettori, la curation della qualità e la produzione di contenuti originali e innovativi, unita ad altre strategie mirate (newsletter tematiche, organizzazione di eventi, formazione), possano fare la differenza. E, magari, garantire anche la sostenibilità.
ilC: L’attuale necessità, specie per i pure players, di diversificare tanto nelle loro attività per potere essere sostenibili è un rischio che può portare ad uno snaturamento del giornalismo o semplicemente è un effetto collaterale che dobbiamo accettare senza grosse preoccupazioni?
NB: Come detto sopra, credo che la diversificazione non sia affatto un male. L’importante è farla con criterio, scegliendo bene quali sono i canali più di valore per il proprio pubblico di riferimento.
ilC: Facebook come salvatore del giornalismo, paradiso dove l’advertisement sembra ancora avere un futuro (si pensi al fatto che presto sarà possibile monetizzare i click anche direttamente da Facebook), oppure creatore di dipendenza e di polverizzazione del pubblico (che ora accedono in modo più orizzontale alle news, proposte loro dai newsfeed algoritimici)?
NB: Facebook ormai non rappresenta più una sola cosa, ma tante cose diverse (spesso in contraddizione tra loro): è un alleato e un nemico delle testate giornalistiche, un rivenditore di pubblicità, ma anche un parassita etc. E lo stesso vale anche per Google, Apple, Amazon, che qualcuno giustamente definisce i Quattro Cavalieri dell’Apocalisse del nuovo scenario digital.
Quel che è certo è che Facebook (come Google) non andrebbe mai considerato come un ulteriore canale di distribuzione dei propri contenuti. Anche se a Menlo Park è proprio questa l’ultima, e più aggressiva, strategia: convincere gli editori a cedere la totalità dei loro contenuti.
Ed è proprio su questo fronte che vedo molte testate rassegnarsi a un atteggiamento autolesionista: perché distribuire i propri contenuti su una piattaforma che da un momento all’altro potrebbe cambiare le regole del gioco?
Facebook andrebbe piuttosto valorizzato come una piattaforma sociale nel suo senso più puro: e, cioè, il luogo in cui coltivare il rapporto con la propria community, continuare la conversazione avviata sul sito, creare meccanismi di effettiva partecipazione e inclusione di più voci nel processo di notiziabilità.
ilC: Infine, secondo te, qual è un esempio di testata online italiana che ha saputo ben cogliere la sfida del digitale?
NB: Non c’è una testata sola che sia riuscita ancora a pieno a cogliere le sfide del digitale. Non abbiamo avuto nessun Mediapart, per dire.
Però ci sono diverse testate digital-only che apprezzo perché hanno sperimentato, si sono sporcate le mani e pian piano stanno costruendo una propria community di riferimento. Penso a Il Post (di cui mi piace l’approccio curatoriale e la capacità di intercettare/creare i bisogni della community che rappresenta), a Slow News (di cui mi piacciono molto le newsletter e l’idea di membership come costruzione di una community con cui dialogare continuamente). Mi piace molto anche Vice e sono curioso di vedere come andrà l’avventura di Vice News Italia.
ilC: Grazie Nicola, a presto!