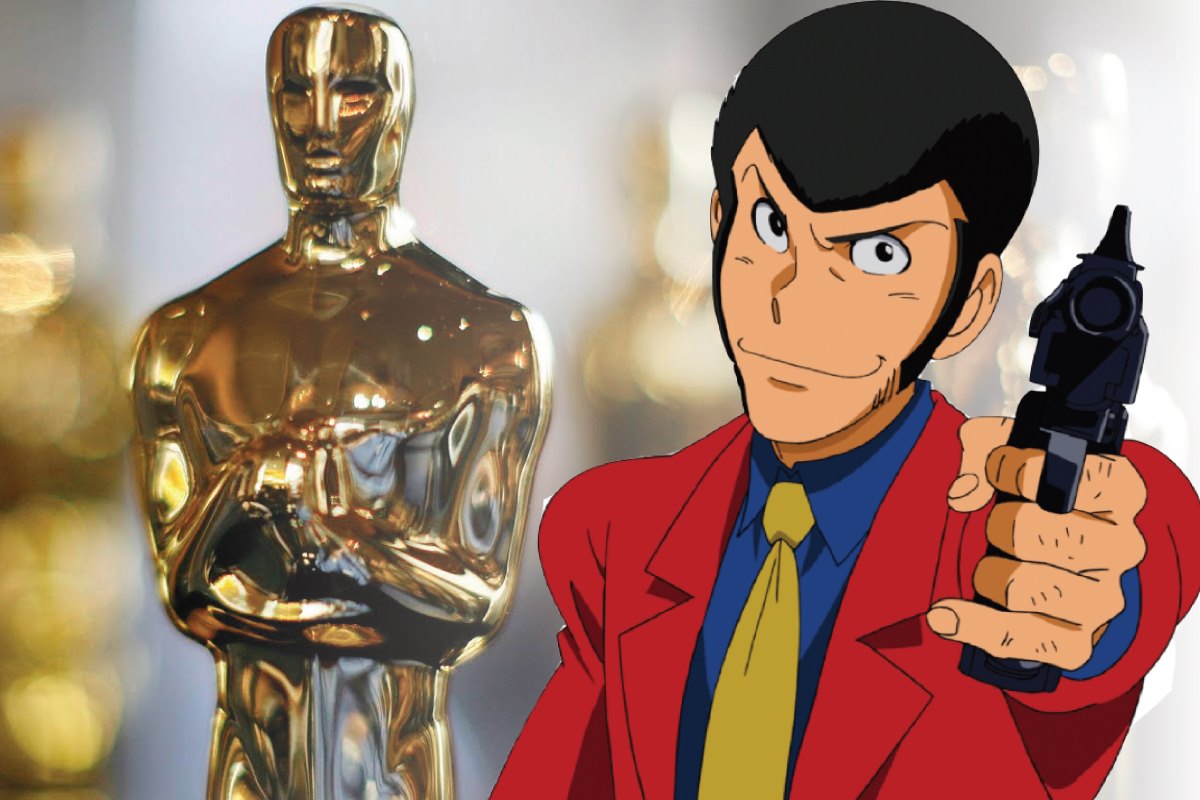Quella di Rodrigo Roa Duterte è una lotta senza quartiere alla droga. Una lotta sanguinaria e inumana.
“God damn the pusher man”
“Well, now if I were the president of this land you know, I’d declare total war on the pusher man”, cantava John Kay, frontman degli Steppenwolf, in piena Summer of Love. The Pusher è un brano che ha incantato milioni di fan e che forse ha lasciato un ricordo indelebile anche nella memoria di Rodrigo Roa Duterte, 16° presidente della Repubblica delle Filippine. La guerra senza quartiere ai trafficanti di droga è stata la spina dorsale della campagna elettorale che lo ha premiato conferendogli la carica più importante dello Stato, lo scorso 30 Giugno 2016. E Duterte, al contrario di molti dei suoi omologhi, ha voluto mantenere la promessa fatta agli elettori. Il giorno dell’insediamento, “the punisher” ha comunicato agli ufficiali della polizia di “fare il loro dovere” e che sarebbe stato lui a proteggerli qualora la caccia al dealer avesse provocato “1000 morti”. Il problema è che il bilancio aggiornato ammonterebbe già a più di 3000 vittime di cui spesso non è chiara l’affiliazione al crimine organizzato. Ad aggravare la situazione è stato l’appello di Duterte all’azione civile contro presunti spacciatori che ha portato a numerose esecuzioni extragiudiziarie. E anche in questo caso, l’immunità per i vigilantes che agiscono in nome delle nuove liste di proscrizione è garantita dall’esecutivo. Nel frattempo, cadaveri con tanto di cartello “pusher” scritto a caratteri cubitali si accumulano per le strade.
Contestato da gran parte della comunità internazionale per questa colossale violazione dei diritti civili, il presidente delle Filippine ha utilizzato la sua retorica tagliente per invitare vari esponenti, tra cui Obama e Papa Francesco, a non immischiarsi nella politica interna di uno stato sovrano.

«Sono il presidente di uno stato sovrano, ed è da molto tempo che non siamo più una colonia. Non ho nessun padrone al di fuori dei cittadini filippini, nessuno di nessuno. Devi avere rispetto. Non devi fare domande. Figlio di puttana, ti insulterò in quell’incontro».
Il raffreddamento delle relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti ha fatto, peraltro, da contraltare a un avvicinamento delle Filippine ai suoi rivali storici: Russia e Cina. In altre parole, le implicazioni di questa crociata hanno effetti sovranazionali profondi che però non sembrano turbare la gran parte dei filippini che preferiscono “un pò d’azione al totale immobilismo”. Un’opinione diffusa che ha legittimato Duterte a richiedere una proroga di 6 mesi per poter “uccidere tutti” i trafficanti di droga.
Una terapia d’urto è indispensabile per sradicare un male incurabile, direbbe qualcuno. Tuttavia, la popolazione filippina non abusa e non assume comportamenti devianti più delle altre. Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine, il consumo di anfetamina da parte dei giovani è relativamente elevato, mentre quello di oppiacei e cocaina è praticamente inesistente. Inoltre le statistiche sul numero di crimini violenti e di stupri dichiarati tratteggiano un paese virtualmente meno pericoloso del Regno Unito.
Per comprendere l’efferatezza della guerra al contrabbando di stupefacenti in atto nelle Filippine, è necessario guardare al passato del suo presidente. Sindaco di Davao City per 22 anni consecutivi, Duterte è noto per il suo accanimento contro i criminali e per aver costitutito la famigerata “Davao Death Squad”. Questa unità speciale di vigilantes e bounty killers costituiva il braccio violento della legge, come ha spiegato il pentito Edgar Matobato di fronte al Senato. Dalle ricostruzioni, parrebbe che più di un delinquente sia finito in mare sbudellato per nutrire i pesci o ancora dei coccodrilli. Quanto a Duterte, in un’occasione avrebbe addirittura scaricato due uzi su un impiegato del dipartimento di giustizia che giaceva a terra ferito dopo uno scontro con Matobato.
Ma il “Donald Trump asiatico”, come lo hanno soprannominato i media, non è solo un supposto carnefice. La sua condotta politica lo rende un mosaico di opinioni apparentemente inconciliabili, tra machismo, progressismo e demagogia. Per esempio: lo scorso aprile, in piena campagna elettorale, Duterte ha scherzato sullo stupro che è costato la vita ad una religiosa australiana alcuni anni prima. D’altra parte, l’ex sindaco di Davao si è mobilitato in prima persona perché le donne abbiano accesso a funzioni politiche e ha adottato vari decreti per facilitare il loro accesso all’impiego. Durante un’intervista si è poi detto a favore del matrimonio tra cittadini dello stesso sesso e dell’aborto, due argomenti tabù in un paese ferventemente cattolico. Che siano complici le molestie subite in adolescenza da un sacerdote? Speculazioni a parte, non è semplice catalogare un personaggio che si batte per i diritti delle minoranze musulmane della sua regione e che al contempo pattuglia la città in sella alla sua moto, reinterpretando il significato della nozione di presunzione di non colpevolezza.
Ad ogni modo, la campagna lanciata da Duterte non costituisce un precedente nella regione. La Tailandia ha già condotto la sua guerra contro il traffico di droga nel 2003: come riporta il Time, nel solo primo mese si contavano 1200 morti, 13000 arresti e 36000 costituiti. Anche l’Indonesia ha avuto il suo “momento di gloria” nei lontani anni ’80, quando migliaia di persone sono state assassinate da penenmbak misterius, vigilantes non identificati. Ciò che accomuna queste due esperienze è la relativa incapacità di estirpare il male alla radice, innaffiata da un insensato bagno di sangue. Il governo delle Filippine avrebbe potuto apprendere dagli errori dei suoi vicini e invece ha optato per la soluzione drastica ad un problema la cui portata è tutta da rimettere in prospettiva. Oltre al danno irreparabile di questa violazione dei diritti umani, il prezzo che Duterte sembra essere disposto a pagare è l’isolamento sul piano internazionale.
*****
Se ti è piaciuto questo articolo leggi anche: Perchè ci droghiamo?