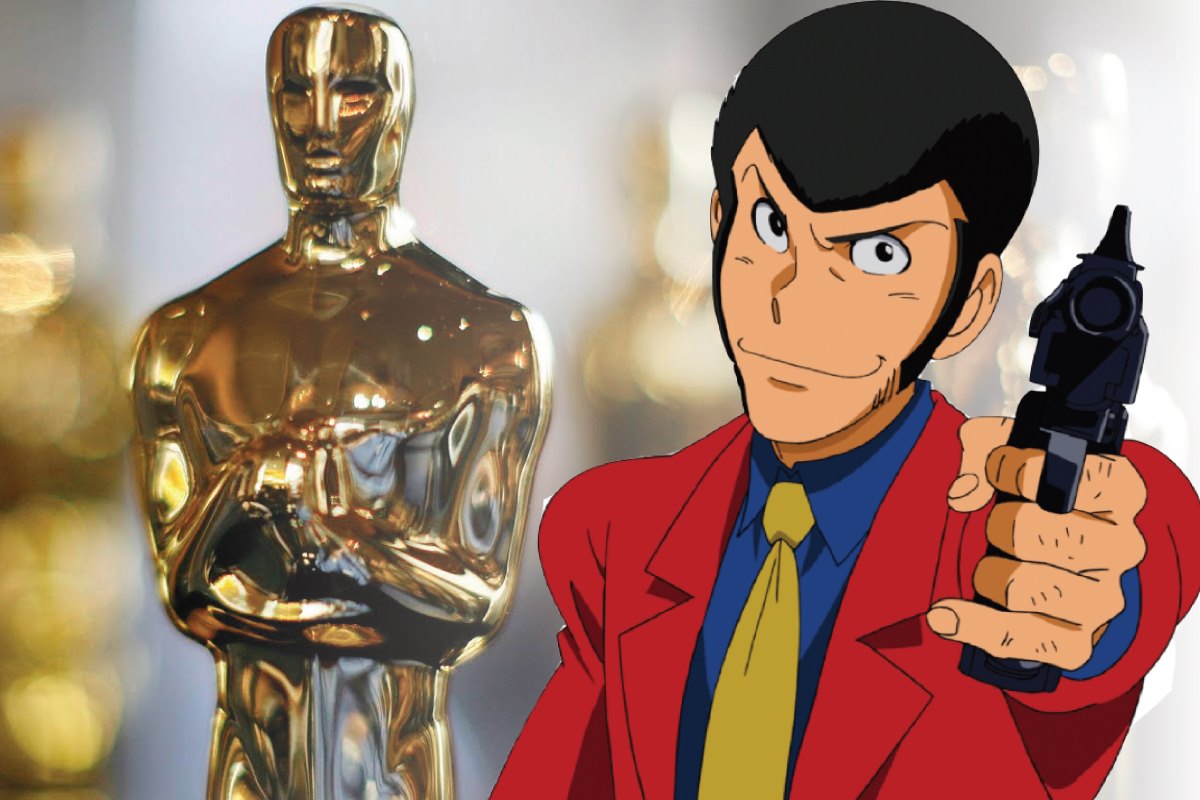Almodóvar, le donne e un destino beffardo mai compreso.
Dopo aver toccato il punto più basso della carriera con i due precedenti film, era lecito aspettarsi da Almodóvar una, seppur parziale, rinascita. Il regista spagnolo va sul sicuro, si affida al terreno a lui più congeniale, ovvero quello del melò familiare spinto, con un racconto fatto di storie di donne, di madri, di ritratti femminili introspettivi e dolenti, dove gli uomini restano gaudenti accessori, elementi sì funzionali alla narrazione, ma mai abbastanza profondi e sensibili. Presentato di recente al Festival di Cannes e ispirato ai racconti tratti da In fuga di Alice Munro, l’autore plasma su paesaggi, volti e luce iberici, il dramma di una figlia che improvvisamente decide di scomparire, mette in scena un dolore sospeso e ingiustificato, un destino beffardo e mai compreso. Citando ironicamente se stesso, avrebbe potuto intitolarsi Niente su mia figlia. Il film è un ritorno ai temi cari, quelli presenti anche nella “trilogia del dolore” a cavallo del millennio, senza però raggiungere i vertici assoluti di Tutto su mia madre o Parla con lei: epistolari intensi e rivelatori (la genuinità naïf delle lettere scritte a mano, una costante), deus ex machina a decidere le sorti, amore, morte, passione, assenza.
E su tutto, aleggiano l’incertezza e il senso di colpa, i sentimenti che maggiormente determinano il tono dell’opera, mesto e tragico. Non mancano, e non potevano mancare, riferimenti all’omosessualità (stavolta non esplicitata) e una frecciatina ai gruppi spirituali, in parte complici del distacco. Lo stile è essenziale, chiaro, adeguato certamente allo scopo, elegante tra le righe. La semplicità ha anche però un prezzo, concretizzato in alcune trovate cinematografiche talvolta collaudate e prevedibili (flashback, ellissi temporali senza soluzione di continuità), nonché una presenza troppo invasiva della musica di sottofondo (del pur bravo e fidato Alberto Iglesias), come pure una seduzione ‘facile’ grazie alla bellezza delle attrici. C’è, però, da dire che il suo non è mai stato un cinema di regia esposta, ma riconoscibile prima di tutto per le storie intense e i personaggi, che siano essi bizzarri, eccentrici o afflitti. Domina la luce, a dispetto dello stato interiore e si fa notare il bianco, nella neve, nelle onde, negli interni, nei vestiti di Julieta. La cosa migliore del film resta, soprattutto nel secondo tempo, il dosaggio e la gestione dello svelamento dei colpi di scena, la ricomposizione dei tasselli narrativi mancanti, la partecipazione empatica chiesta allo spettatore, internamente focalizzato e del tutto ignaro, alla pari della protagonista. Ritroviamo attrici e attori feticcio, come la fedelissima faccia picassiana Rossy De Palma e Darío Grandinetti. La scena è però tutta per lei, Julieta, sia nella veste giovane interpretata dalla bellissima Adriana Ugarte sia in quella matura con il volto segnato di un’intensa Emma Suarèz.