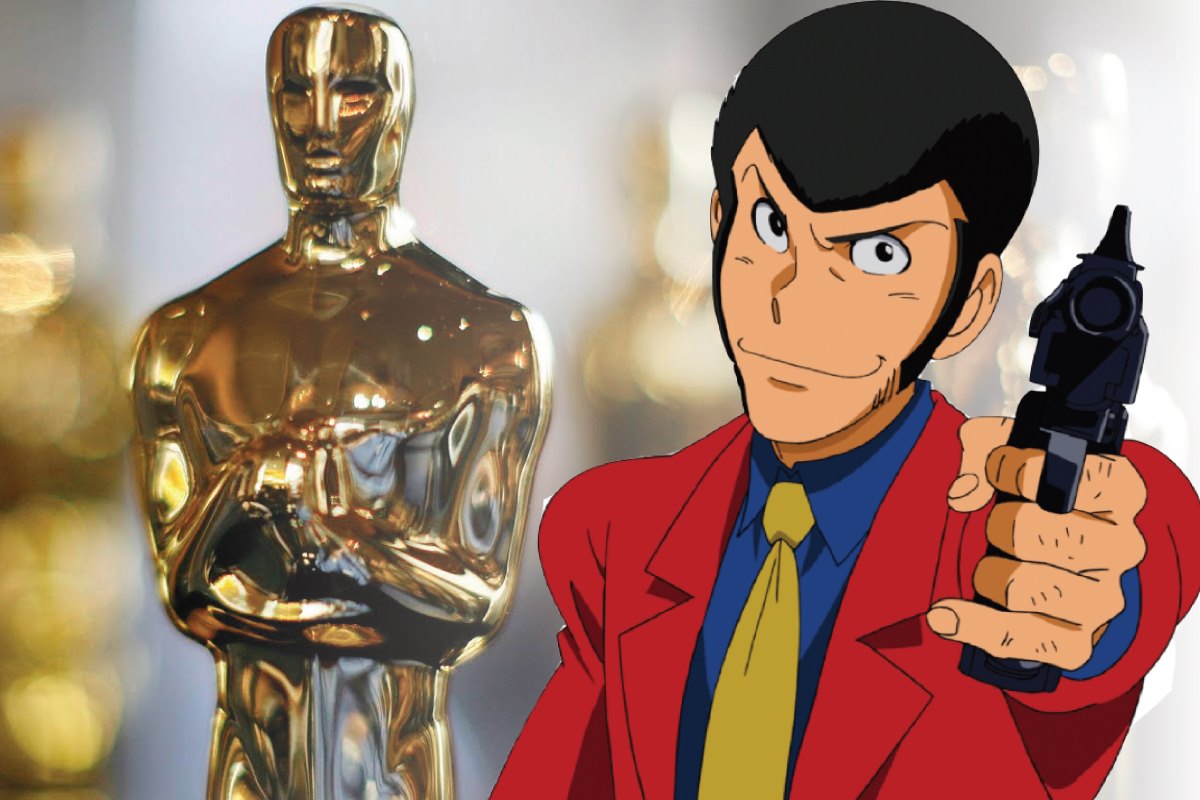La nostra ottava menzione d'onore, L'orgoglio del pregiudizio di Martina Maugeri, è una cruda analisi della società odierna e delle sue etichette.
Era l’anno delle stragi di Capaci e via D’Amelio, l’anno dello scandalo di Mani Pulite, anni, insomma, in cui ancora la magistratura contava qualcosa, contava tanto da mettere a disagio i riposi notturni di capicosca e delinquenti dai colletti bianchi. Era questo l’anno in cui Ester fu data alla luce, quasi a voler segnare in qualche modo il suo percorso. Nata per la giustizia, partorita dal ventre squarciato di una madre patria dalle membra stanche e affaticate.
Una madre patria che dalla sua nuova generazione cercava speranza, richiedeva fiducia e i cui sogni si preparava a stroncare una volta che tutti i piccoli cittadini fossero giunti all’età della maturità.
Che generazione quella di quell’anno! Erano nati in un periodo di transizione, un periodo in cui nessuna certezza poteva delinearsi all’orizzonte, se non quella dell’assoluta instabilità. Come avviene per ogni decennio di fine secolo, anche quello del XX secolo aveva iniziato a dare i segni di un forte squilibrio che si sarebbe protratto per una buona parte del nuovo millennio. Il giorno di Capodanno del terzo millennio la gente mormorava che sarebbe giunta la fine del mondo e nessuno avrebbe visto l’alba della nuova era. Così gente che richiedeva prestiti, gente che sconfessava peccati che altrimenti avrebbe volentieri portato con sé nella tomba, persone che liberavano i propri istinti più repressi, noncuranti delle conseguenze. Che catastrofe svegliarsi il giorno dopo e scoprire che l’anno 2000 era arrivato e aveva portato solo tanti problemi! Tutti problemi creati dalle dannazioni cui questo nuovo millennio era stato condannato e a cui mai si sarebbe sottratto.
Iniziò, infatti, a spargersi l’idea che fosse un’era maledetta, e nessuno si impegnò mai a smentire tale credenza, anzi, proprio il contrario! Considerato come il recipiente cronologico in cui riversare tutte le debolezze, le delusioni e le distruzioni che l’uomo moderno possa creare, il primo decennio di questo nuovo secolo si apprestò ad offrire ai nati sotto la stella di Tangentopoli anni poco luminosi in cui iniziare a conoscere il mondo e farsene un’idea.
Generazioni a metà, ecco cosa erano Ester e i suoi coetanei. Generazioni nate a metà tra il vecchio e il nuovo, nate tra il nove e lo zero, tra la fine e l’inizio. Avevano potuto vedere e toccare con mano gli sgoccioli di un secolo barbarico e gli inizi di un altro, la cui vera natura cruenta tutti cercavano di nascondere dietro la maschera della difesa della pace, ergendo lo stendardo della solidarietà. Appartenevano a quella gente che, per ultima, poteva vantare di aver conosciuto la Lira e di aver vissuto il periodo del cambio valuta, un terrore per gli anziani e un po’ per tutti gli italiani che temevano la truffa… esperti com’erano a farne di loro! Potevano orgogliosamente vantare di aver imparato a vivere in strada, con la gente reale che rimprovera per una marachella ed elogia per un nonnulla, avevano bisticciato per un giro in bici o una caramella rubata e portavano addosso i segni di tante sconfitte a calcetto o a nascondino. Si erano, poi, ritrovati all’inizio dell’anno zero del mondo moderno tecnologico, un periodo questo che rende maggiormente consapevoli della crescita e decrescita cui il genere umano è giunto. E molti di loro non si rendevano conto di quanto fosse apocalittico il cambiamento che stavano attraversando.
Ma per Ester e per i suoi coetanei concittadini, alla già grande complessità nel cambiamento di vedute e principi che tutta quella generazione dovette affrontare, si affiancò un altro enorme ostacolo: la piccolezza del territorio in cui si trovarono a crescere e la ristrettezza d’opinioni che si trovarono a smascherare e superare.
Vivevano in un paesino delle coste siciliane, che contava circa settantamila anime, numero che da qualche anno aveva dato agli abitanti l’orgoglio di definirsi cittadini, non più paesani. Definizioni. Era tutta una questione di definizioni in quel piccolo anfratto di territorio, delimitato da fiumi e campagne e limitato da schemi e prototipi. Definire una persona seria e quindi descrivere la serietà; definire la rispettabilità di un uomo, delineando l’ambito di operatività del rispetto; definire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, senza mai lasciarsi sfiorare dall’idea pirandelliana del relativismo. Dare una definizione di tutto e tutti, inquadrare ogni cosa entro delle categorie precostituite e per ciò stesso inconfutabili e irrinunciabilmente perfette. Arrivare a dare persino una definizione di violenze domestiche legittime, come se ne possano esistere, e quindi attribuire responsabilità colpevoli a donne picchiate, maltrattate da uomini tipo schematizzati e ritenuti rispettabili.
E fu proprio all’interno di questa matassa inestricabile di preconcetti, pregiudizi, prese di posizione ingiustificate, che Ester dovette iniziare ad affrontare la vita, credendo che tutto si risolvesse in un meccanico catalogare di persone, condannate dalle loro stesse espressioni a marcire nella bolgia inumana del pregiudizio. Il filo d’Arianna che permise ad Ester di uscire da questo labirinto di sguardi maledetti, di gente “da evitare”, fu la sua curiosità e la voglia incessante di conoscere per capire, senza lasciare che fossero gli altri a capire per lei. Pian piano iniziò a discostarsi da quanto vedeva e sentiva e scoprì che oltre i libri, e molto più di questi che invece possono servire da strumento, la cosa più bella da leggere e conoscere è la gente. Imparò che l’anima delle persone è ricca di sfaccettature e sorprese, pregna di significati nascosti e sentimenti inespressi, e scoprì che cogliere i dettagli di ognuna di loro attraverso le parole lasciate a metà o gli istinti frenati, è la giusta chiave di lettura delle loro storie. Storie di donne violate, di uomini traditi, di bambini offesi che non erano scampati alla condanna dei “cittadini”. Tutte storie, dunque, che meritavano un riscatto sociale.
Accadde così che Ester e la sua riscoperta capacità di critica furono messe alla prova quando, in una fredda giornata di dicembre, fu rinvenuto il cadavere di un uomo. Quel giorno i cittadini si svegliarono con la sconvolgente notizia della morta di “Linuzzo”, il barbone che tutti conoscevano e opportunamente tenevano a debita distanza. Chi aveva il coraggio di frequentare le strade in cui lo si poteva trovare sapeva benissimo di dover cambiare marciapiede per evitare di scontrarsi con lui; nessuno osava guardarlo negli occhi per paura di rimanere impietrito, quasi fosse Medusa. Era a lui che le mamme si riferivano quando volevano costringere i figli a fare qualcosa:
“Mangia i broccoli, altrimenti viene Linuzzo e ti mangia”.
Linuzzo era, insomma, l’incubo di tutti e rientrava perfettamente nella categoria dei falliti, della gente da evitare ad ogni costo; forse alla notizia della sua dipartita molti sospiri si levarono in alto.
A prima vista la sua morte fu ricollegata ad un malore improvviso, salvo poi scoprire che il suo corpo era pieno di lividi e tagli difficilmente compatibili con un infarto, così come difficilmente compatibili con una morte naturale erano le innumerevoli fratture che Linuzzo riportava. In città si mormorava il peggio e nulla evitò di dar prova del fatto che più che tra cittadini si stesse parlando tra paesani. Le donne che stendevano i panni, i fruttivendoli agli angoli delle strade, gli uomini al bar e i vecchietti al circolo della briscola non facevano altro che interrogarsi e indagare sulla scomparsa improvvisa di un uomo di cui non si erano curati per anni. A sciogliere ogni dubbio furono le indagini della polizia che brillantemente archiviò la cosa come caso irrisolto di omicidio. Omicidio con vittima ma senza colpevole. Furono tutti più tranquilli allora a sapere che la morte di Linuzzo aveva un senso; erano tutti più tranquilli a sapere che c’era un omicida a piede libero. Ma erano tutti più tranquilli perché in questo modo avrebbero avuto un’altra di quelle etichette da attaccare alla gente, ché ormai erano stanchi di usare sempre le stesse. Vi andò di mezzo qualche membro sventurato di famiglie di ultimo rango, che si ritrovò silenziosamente, e senza saper nulla, privato della qualifica di buon cittadino e con la fedina penale metaforicamente sporca… senza prescrizioni né amnistie, ché il giudice popolare non è abituato a questi mezzucci garantisti.
Per fortuna (o per disgrazia di taluno) non passò molto tempo che qualcuno si presentò alla polizia, coda tra le gambe e occhi fissi alle ginocchia, per ammettere le proprie colpe. Jeans scuri, camicia a quadri e giubbino all’ultima moda, qualche peletto sul viso e dei brufoli sulla fronte. Uno dei due che si presentarono in caserma aveva il cappuccio verde della felpa tirato su per il capo, quasi a voler coprire la vergogna di quei diciassette anni gettati al vento in una fredda sera di dicembre. Si costituirono senza se e senza ma, ammisero di essersi intrufolati in quella che era la casa di Linuzzo e lo avevano massacrato di botte e umiliato solo perché non sapevano cosa fare. Noia. Voglia di distrarsi. Divertimento. Sfida. Furono queste le parole che utilizzarono per giustificare “l’accaduto”, come se l’accaduto riguardasse il furto di una mela.
I ragazzi furono sottoposti al loro giusto processo e furono adottate tutte le precauzioni del caso visto che si trattava di imputati minorenni. Il processo si concluse con la loro giusta condanna e le porte del carcere si aprirono dinnanzi ai loro occhi bambini per riaprirsi soltanto alle loro nuche brizzolate.
Ovviamente la condanna del paese/ città non tardò ad arrivare. Non appena si sparse la voce che due minorenni si erano costituiti per l’omicidio di Linuzzo, tutti pensarono a quel famoso figlio di famiglia disgraziata che già era passato sotto il giudice popolare. Quale sventura fu scoprire che si trattava del figlio del loro medico di famiglia e del cartolaio sotto casa, che in un freddo lunedì d’inverno si erano ritrovati tristi e insoddisfatti delle loro vite auree e avevano organizzato una lapidazione pret-a-porter! E se prima la vita di Linuzzo valeva troppo per essere sacrificata alla Dea Viltà, quando si scoprì che il dottor Tizio e il cartolaio Caio erano indirettamente coinvolti, tutti smisero di parlare di Linuzzo, dell’importanza della sua vita e della tristezza della sua morte. Non si parlò più dell’ingiustizia perpetrata ai danni di un uomo innocente, né si parlò delle de-generazioni che quel paese/città stava creando; non si disse nulla riguardo al fatto che magari Linuzzo avrebbe meritato un degno ricordo. La faccenda fu archiviata come una bravata tra ragazzi e le donne che stendevano i panni tornarono a parlare di telenovelas e matrimoni.
Linuzzo scomparve dalla memoria collettiva e, come del resto era stato in vita, divenne solo un fantasma. La cosa che più fece inorridire la nostra protagonista fu vedere come un’intera città di settantamila abitanti che amava definirsi civile aveva avuto il coraggio di processare e condannare senza appello un povero innocente disgraziato per giustificare la morte di un altro disgraziato come lui, ma non aveva poi mai puntato un dito contro due giovani di buona famiglia. Ritornavano le etichette, ritornavano i pregiudizi e le violenze legittime, ritornava la tolleranza e ritornava la becera ipocrisia.
Ester non si diede pace. Cercò notizie di quell’uomo per mesi, chiese dettagli sulla sua vita a chiunque gli avesse rivolto la parola e scoprì che quell’uomo aveva una storia. Una di quelle storie che non lasciano preludere un lieto fine.
Aveva un nome, un cognome, una data di nascita e tante delusioni disseminate in quarantadue anni di vita. Aveva avuto una madre, un padre, un fratello e un cane. Aveva avuto una moglie, ma lo aveva tradito col fratello. Insieme erano fuggiti e lo avevano lasciato in quell’enorme casa vuota che Linuzzo aveva trasformato in discarica. Aveva perso il lavoro a causa della depressione in cui era caduto e la sua mente aveva per sempre abbandonato questo mondo. Ecco perché viveva da straccione. Amava gli animali e solo questo lo faceva restare in vita.
Era una persona buona, innocua e innocente. Vittima degli uomini aveva continuato a vivere tra loro, aveva continuato a fidarsi di loro finché una gelida sera di dicembre la storia gli aveva presentato il conto: due maldestri assassini con un sacco di pietre e tanta insoddisfazione addosso. Aveva bruciato nella bolgia degli inetti in vita senza che nessuno lo degnasse di considerazione o gli porgesse la mano, e diventava un martire dopo la morte per poi essere subito gettato in pasto all’oblio. La sua vita, né la sua morte evidentemente, valevano tanto da impegnare la memoria collettiva.
E così Ester iniziò a guardarsi in giro e vide solo dei fantasmi con delle etichettatrici in mano e un macigno di pochezza sulle spalle, che prezzavano il costo della loro dignità. Questa era la definizione che meritavano i cittadini: fantasmi di carne, fatti solo di ossa e privi di anima, condannati a bruciare tra le fiamme della loro stessa incapacità di essere umani.
Parole di
Martina Maugeri
*****
Se il nostro concorso letterario ti appassiona leggi anche la settima menzione d’onore, L’asfalto è sempre uguale, il cielo sempre diverso di Simone Napoli.