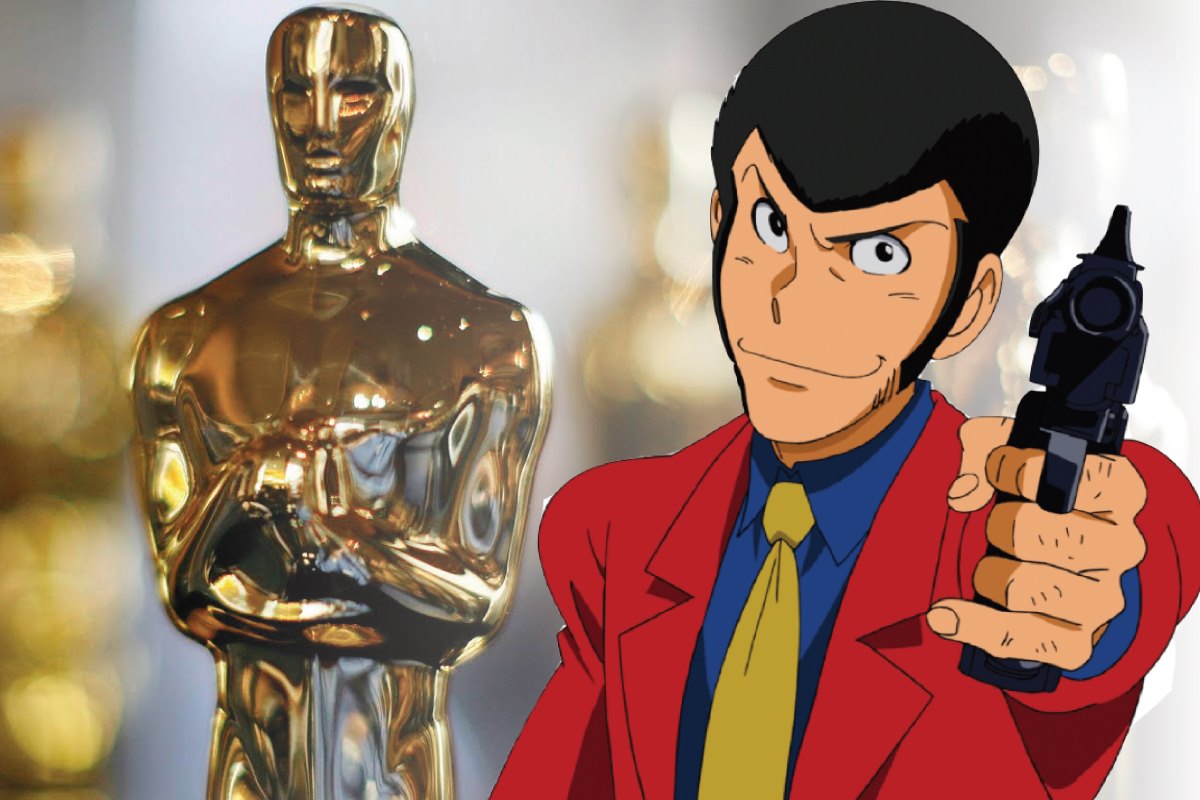Abdellatif Kechicheci mostra tutto ne La Vita di Adele, ma proprio tutto. Nessun dettaglio è precluso alla nostra vista.
È finalmente arrivato nelle sale italiane il film vincitore dell’ultimo festival di Cannes, La vita di Adele, quinto lungometraggio del regista franco-tunisino Abdellatif Kechiche che ritorna ai temi a lui più cari (momentaneamente accantonati negli ultimi due film Cous Cous e Venere Nera), quelli degli esordi, quelli, per intenderci, di Tutta colpa di Voltaire e, soprattutto, de La schivata. Protagonista, oggi come allora, è l’adolescenza (meglio, gli adolescenti) vivisezionata con chirurgica destrezza (l’identicità di contenuto, per la verità, non si esaurisce qui. Ritornano, infatti, Marivaux e il determinismo classista). Le doti di Abdellatif Kechiche come indagatore delle relazioni umane e come abile tessitore di veri e propri romanzi di formazione (i suoi film potrebbero sembrare quasi dei trattati antropologici) ci erano già ben note e si erano mostrate con assoluta chiarezza nello straordinario La schivata, dove nello squallido teatro delle banlieu parigine il giovane Krimò viveva l’esperienza di un amore non corrisposto. Se già quello poteva sembrare un film pressoché perfetto, dobbiamo (con piacere) constatare che Kechiche è riuscito a fare meglio condensando in quasi tre ore di puro cinema (anche le doti di narratore oltre che dialoghista sono ormai una certezza) una storia che toglie il fiato per quanto è bella, vera, commovente.
La giovane studentessa liceale Adele (Adèle Exarchopoulos) scopre lentamente, e noi insieme con lei, la sua identità omosessuale perdendosi (ed allo stesso tempo ritrovandosi) in una appassionante storia d’amore con la più matura ed esperta Emma (Léa Seydoux). Storia d’amore che è catturata e restituita in splendide sequenze di corpi che si avvinghiano, mani che si toccano, occhi che si cercano (da vedere e rivedere all’infinito la sequenza in cui Adele entra in un bar gay con la speranza di ritrovare la ragazza dai capelli blu che ha incendiato il suo cuore). Nessun dettaglio è precluso alla nostra vista, Kechiche ci mostra tutto, ma proprio tutto (qualcuno ha storto il naso, specie per le lunghissime scene di sesso lesbico; altri hanno addirittura parlato di voyeurismo) e pur tuttavia niente di quello che vediamo sembra sovrabbondante, di troppo; ma tutto pertinente, necessario. E questo è vero sia per quanto riguarda le scene degli amplessi (mostrate con dovizia di particolari) sia per quelle apparentemente meno importanti (dal punto di vista diegetico) come ad esempio un pranzo in famiglia.
Alla fine, come tutti sappiamo, è la vita che dà ed è la vita che toglie; ma i ricordi, indelebili, quelli restano, cosi come restano le opere d’arte, soprattutto se raffiguranti un momento, un attimo, eterno, di felicità. E ad Adele, diversamente da Krimò, quell’attimo, è stato concesso di viverlo. Ed è con questa consapevolezza che alla fine Adele si allontana dal suo presente che è già passato, incamminandosi verso un nuovo inizio. Un altro capitolo di quella (stra)ordinaria storia che è la vita.
Che bello, il cinema, quando riesce semplicemente a raccontare storie, stupendoci, commuovendoci. Grazie dunque a Monsieur Abdel per averci concesso lo straordinario privilegio di essere stati testimoni della nascita, della maturazione e della fine del sentimento più bello e più intenso che il cinema possa raccontare: l’amore. Che poi sia anche omosessuale non fa alcuna differenza; anzi, forse lo rende ancor più prezioso.